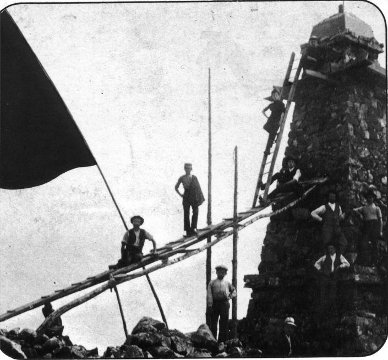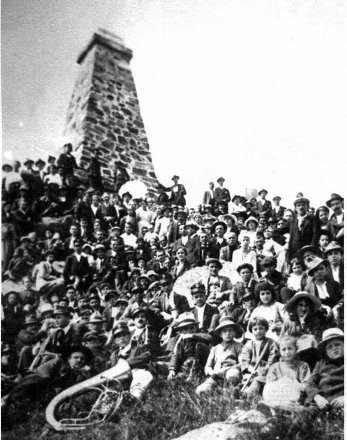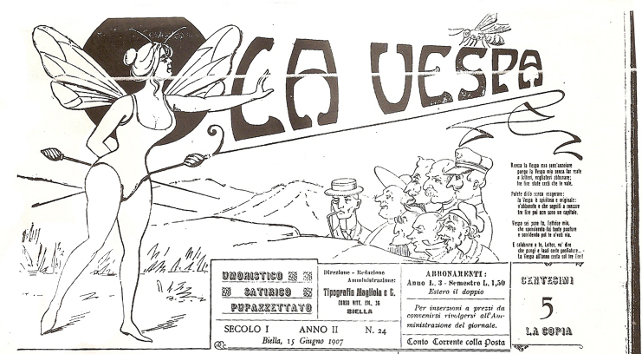QUADERNO N. 37
INDICE
INTRODUZIONE
DOLCINO E GLI APOSTOLICI, LA STORIA IN BREVE
DOLCINO, CIVILTA’ MONTANARA
E AUTONOMIA BIOREGIONALE
LONGINO CATTANEO ed il MOVIMENTO
DOLCINIANO 700 ANNI DOPO
STRALCI DEI GIORNALI BIELLESI
APPENDICE
ARTICOLI DI PAOLO SECCO PUBBLICATI SU OUSITANIO VIVO
SU TEMA DELLE ERESIE NEL CUNEESE
Quaderni CIPEC
Attività CIPEC
INTRODUZIONE
Con questo numero,
riprendiamo la regolare pubblicazione dei nostri quaderni.
La comunicazione, da
parte dell’amministrazione provinciale, della decisione di
interrompere la pubblicazione, iniziata nella lontana primavera 1995,
ci ha portati a stampare, con le nostre forze, due quaderni che erano
pronti e di particolare attualità: quello per gli ottant’anni di
Gianni Alasia, celebrati (febbraio) nella sala Viglione del palazzo
del Consiglio regionale e quello sull’inchiesta circa la Lega
nord nel cuneese, uno dei fenomeni certamente più complessi
dello scenario politico provinciale.
La scelta
dell’amministrazione provinciale è poi rientrata e ci è stato
comunicato che potremo usare ancora la Stamperia della provincia per
la durata di questo mandato amministrativo (sino al 2009) per due
pubblicazioni all’anno.
Ringraziamo senza
formalità la Giunta provinciale, in specifico l’assessore alla
cultura Valsania e il presedente Costa, così come abbiamo fatto, per
il periodo 1995-2004 con il presidente Quaglia. Con loro, il
personale della tipografia provinciale a cui abbiamo spesso portato
(modesti) aumenti di carico di lavoro.
Ribadiamo la natura della
nostra iniziativa: fornire documentazione, valutazioni, informazione
su tanti aspetti della vita politico-sociale-culturale,
concentrandoci in gran parte sul cuneese, senza mancare di toccare un
quadro più ampio.
Chi volesse scorrere
l’indice dei 36 numeri usciti ad oggi, potrebbe trovare la storia
della locale sinistra politica nel dopoguerra, studi sui dati
elettorali, testimonianze di tanti/e militanti (quante si sarebbero
perdute se non le avessimo raccolte?), a dimostrazione che la storia
è fatta di tante vicende individuali, ognuna significativa, che, in
alcune circostanze, si sommano e producono processi collettivi.
La figura di Michele
Risso, oggetto di alcuni quaderni (due convegni a Boves e la
pubblicazione di alcuni suoi scritti) non è politico-partitica, ma
assume una valenza politica di non poco conto sia per la grande
importanza, non solo nazionale, del movimento di cui ha fatto parte,
sia per la attualità dei temi toccati (la malattia mentale, la
sofferenza, l’emarginazione…). Doveroso ricordarne vita ed opera,
soprattutto in una realtà locale che lo ha sempre sottovalutato ed
in un clima complessivo che sembra volutamente cancellare, o almeno
ignorare, le esperienze più significative che abbiamo alle spalle
(quanti/e studenti/esse di psicologia conoscono oggi l’impegno
“epocale” di Franco Basaglia?).
Atipico il quaderno su
Alberto Manna, consigliere provinciale di Forza Italia,
prematuramente scomparso, di cui è parso giusto riportare gli
interventi nell’assemblea locale.
Oltre al locale, alcuni
temi nazionali: il socialismo italiano, atipico e non omologabile per
decenni a quelli europei, i nodi della storia comunista, dal Pci a
Rifondazione, le speranze e le contraddizioni della nuova
sinistra.
Accanto ai quaderni
l’attività del CIPEC, sempre autofinanziata, basata sull’impegno
volontario.
Importante e da
rilanciare e per i grandi nomi che abbiamo avuto l’onore di
ospitare (per tutti/e: Masi, Geymonat, Bellofiore, Spinella, Girardi,
Cortesi, Collotti Pischel, Revelli, Ferrero, Pirella, Santarelli,
Moscato, Meandri, Barbero, La Valle, Carlevaris, Rieser, Dinucci,
Perini, Novelli, Nesi, Agostinelli, Cremaschi) e per le tematiche
toccate, quasi sempre “fuori dal coro”.
Affrontare “senza rete”
e privi di dogmi il discorso della crisi del marxismo, il rapporto
tra questo e nodi “emergenti” (ambiente, femminismo, pacifismo…),
iniziare prima che fosse “di moda” a parlare di globalizzazione o
di emergenza ambientale, presentare libri spesso scomodi, ragionare
sulla psicanalisi senza sposare questa o quella scuola sono per noi
motivo di vanto e di soddisfazione, così come i sei corsi sugli
“anni della nostra storia” (dal 1945 al 1990) che occorrerà, un
giorno o l’altro, continuare con il periodo più prossimo all’oggi.
I prossimi numeri di
questa modesta e spartana pubblicazione intrecceranno le questioni
sopra ricordate: introduzioni a molti convegni e iniziative
pubbliche, memorie di militanti (quanti/e, purtroppo, non ci sono
più?), temi più ampi, a cominciare da quello delle eresie,
soprattutto quelle che hanno determinato ripercussioni più ampie
rispetto alla sola questione “dottrinaria”. Valuteremo e
cercheremo di studiare come la storiografia marxista (Engels,
Kautsky, Bloch) abbia interpretato le grandi sollevazioni popolari
suscitate da personaggi come Müntzer, Jan Hus tanto per citare i
più conosciuti.
Attraverso le sfumature
di Loewenberg, Esch , Lohmann, Hinrichs e altri arriveremo ad
analizzare il nesso tra teologia e rivoluzione; nello specifico dove
termina la componente teologica e inizia il “sovvertimento” dei
rapporti sociali. Certamente si dovrà tenere conto dei limiti
teologici degli studi marxisti e separare l’esaltazione delle
azioni rivoluzionarie degli “eretici” dalla glorificazione della
rivoluzione proletaria.
Di pari passo getteremo
uno sguardo nella poco conosciuta e poco letta “storiografia
illuministica” di queste grandi vicende. Un tentativo di analisi
scientifica della esperienza müntzeriana fu fatto dal pastore
protestante G. T. Strobel, un diretto testimone delle iniziali
rivolte di stampo giacobino nella Norimberga della fine del ‘700 e
successivamente il medico giacobino J. B. Erhard scrisse il suo
“Sul diritto del popolo alla rivoluzione” .
Questo è il compito su
cui sarebbe interessante potersi impegnare in futuro.
In questo numero, come
detto, vogliamo dare il nostro modesto contributo al settimo
centenario del martirio di fra Dolcino, Margherita da Trento, Longino
Cattaneo e a tutti e tutte coloro che in questa vicenda videro un
riscatto dal servaggio temporale del potere religioso allora
dominante.
La figura di Fra Dolcino,
giustamente rivendicata dal movimento socialista al suo sorgere, come
ideale continuità fra la protesta religiosa- sociale del Medio Evo e
le rivendicazioni sociali di un grande movimento emergente che si
riprometteva di cambiare il mondo (quanto paghiamo oggi il fatto che
questo non sia avvenuto o che, in tanti casi, si sia trasformato nel
suo contrario!) è ancor oggi ricordata per la coerenza sino al
martirio, ma richiama la necessità di trasformazione morale e
sociale propria di tanti movimenti ereticali e pauperistici,
convinti, come il primo socialismo che un nuovo mondo fosse alle
porte.
Accanto agli scritti,
nati in occasione di convegni dolciniani ed iniziative, alcune pagine
di vecchi giornali socialisti che ripropongono il sapore e le
tematiche di un mondo lontano eppure ancora così appassionante.
Quindi scritti dell’amico
Paolo Secco, comparsi sul periodico “Ousitanio vivo” e tutti
centrati sulla religiosità della nostra area geografica e su eresie
locali. Pagine poco conosciute che parlano di tensioni, di una fede
religiosa che impronta ogni attimo della vita ed ogni scelta, di aree
dove diverse letture di Dio e dei Vangeli si sono intrecciate e
confrontate, anche drammaticamente
S.D.
Dolcino e gli Apostolici
LA STORIA IN BREVE
( dal
sito - http://fradolcino.interfree.it )
A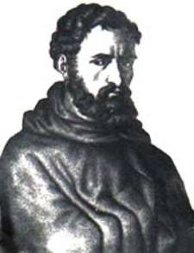 nno
1300: anno del Giubileo e del perdono universale. Perdono per tutti i
malfattori, ma non per Gherardino Segalello, che viene posto al rogo
a Parma. La sua colpa? Aver dato vita al movimento dei "Fratelli
Apostolici". Nel 1260 circa, l'umile Gherardino aveva chiesto di
essere ammesso nel convento dei frati minori (francescani) di Parma.
Permesso rifiutato. Allora vende la sua piccola casa ed il suo
piccolo orto, getta i soldi così ricavati ai poveri (proprio come
aveva fatto San Francesco), ed inizia una vita nuova basata su pochi,
essenziali concetti: l'imitazione di Cristo ("seguire nudi il
Cristo nudo"), il rifiuto di ogni possesso e accumulazione
(quindi la povertà assoluta) e dunque le elemosine in una esistenza
itinerante, nella convinzione che solo una tale realtà esistenziale
potesse interpretare nel giusto modo il messaggio del Vangelo. E' il
rifiuto, messo in pratica, della via adottata dalla chiesa di Roma
(possesso, ricchezza, potere).
nno
1300: anno del Giubileo e del perdono universale. Perdono per tutti i
malfattori, ma non per Gherardino Segalello, che viene posto al rogo
a Parma. La sua colpa? Aver dato vita al movimento dei "Fratelli
Apostolici". Nel 1260 circa, l'umile Gherardino aveva chiesto di
essere ammesso nel convento dei frati minori (francescani) di Parma.
Permesso rifiutato. Allora vende la sua piccola casa ed il suo
piccolo orto, getta i soldi così ricavati ai poveri (proprio come
aveva fatto San Francesco), ed inizia una vita nuova basata su pochi,
essenziali concetti: l'imitazione di Cristo ("seguire nudi il
Cristo nudo"), il rifiuto di ogni possesso e accumulazione
(quindi la povertà assoluta) e dunque le elemosine in una esistenza
itinerante, nella convinzione che solo una tale realtà esistenziale
potesse interpretare nel giusto modo il messaggio del Vangelo. E' il
rifiuto, messo in pratica, della via adottata dalla chiesa di Roma
(possesso, ricchezza, potere).
C ominciano
ad affluire seguaci di Gherardino (il quale tuttavia rifiuterà
sempre di essere considerato "capo", in omaggio ad una
concezione integralmente comunitaria ed antigerarchica), e via via il
consenso popolare cresce, tanto che le file degli Apostolici si
ingrossano e moltissimi, uomini e donne, aderiscono a questo
movimento. Gherardino, nella sua semplicità, è un grande
comunicatore: coloro che aderiscono al movimento vengono privati dei
vestiti e indossano una tunica bianca (l'unica cosa che possiedono),
rifiutano persino, dell'elemosina, il pane superfluo che non può
essere consumato immediatamente, egli stesso si presenta sulla
pubblica piazza attaccato al seno di una donna come fosse un neonato
lattante (a simboleggiare la rinascita dello spirito cristiano in una
nuova éra di purezza totale), fa predicare in chiesa persino i
bambini. Insomma, il contenuto del messaggio degli Apostolici (che si
chiamano anche "minimi" per segnare la differenza con i
"minori"- francescani i quali si erano integrati, in fondo
tradendo l'insegnamento del loro fondatore Francesco d'Assisi, nei
meccanismi potere-ricchezza della chiesa di Roma), e le forme della
predicazione ottengono via via un enorme successo e adesione
popolare, al punto che la gente abbandona i riti cattolici per
affluire in massa alle "prediche" degli Apostolici.
Gherardino invia anche diversi Apostolici a portare il proprio
messaggio in terre lontane. Questo enorme successo (riconosciuto
dalle più autorevoli fonti storiografiche cattoliche dell'epoca) non
può più essere tollerato dalla chiesa romana: il mite Gherardino
(pacifista integrale) viene imprigionato, alcuni apostolici vengono
messi al rogo, e infine, nel 1300, Gherardino stesso viene arso vivo
sulla pubblica piazza, nel nome del Signore. Ma il rogo di Gherardino
Segalello, anziché spegnere il movimento apostolico, per uno di
quegli strani "scherzi" della storia, segna invece l'inizio
di una vicenda del tutto originale, e di enorme portata, nel medioevo
italiano. Tra i molti che erano venuti in Emilia anche da lontano per
partecipare al movimento apostolico, vi è Dolcino, nativo di Prato
Sesia (Novara). Dopo la morte del fondatore, Dolcino di fatto assume
il ruolo di leader del movimento, il cui nucleo "dirigente",
sotto la pressione dell'Inquisizione, si sposta nel 1300 dall'Emilia
al Trentino (vengono chiamati qui ed accolti da loro amici e
compagni). La repressione tuttavia li segue anche lì, ove tre
apostolici (due uomini e una donna) vengono posti al rogo. Nel
1303/1304 ecco allora Dolcino, con il gruppo degli Apostolici più
fedeli (uomini, donne, vecchi e bambini), partire nel lungo viaggio
che li porterà, attraverso le montagne lombarde (presso Chiavenna vi
è tuttora un paese che si chiama Campodolcino) in Valsesia. La
Valsesia è la terra d'origine di Dolcino, qui egli conta amici, ed è
naturale che, per salvarsi, egli pensi a questa meta. Tra le donne
che fanno parte di questo gruppo vi è la bellissima Margherita di
Trento, di nobili origini, compagna di Dolcino.
ominciano
ad affluire seguaci di Gherardino (il quale tuttavia rifiuterà
sempre di essere considerato "capo", in omaggio ad una
concezione integralmente comunitaria ed antigerarchica), e via via il
consenso popolare cresce, tanto che le file degli Apostolici si
ingrossano e moltissimi, uomini e donne, aderiscono a questo
movimento. Gherardino, nella sua semplicità, è un grande
comunicatore: coloro che aderiscono al movimento vengono privati dei
vestiti e indossano una tunica bianca (l'unica cosa che possiedono),
rifiutano persino, dell'elemosina, il pane superfluo che non può
essere consumato immediatamente, egli stesso si presenta sulla
pubblica piazza attaccato al seno di una donna come fosse un neonato
lattante (a simboleggiare la rinascita dello spirito cristiano in una
nuova éra di purezza totale), fa predicare in chiesa persino i
bambini. Insomma, il contenuto del messaggio degli Apostolici (che si
chiamano anche "minimi" per segnare la differenza con i
"minori"- francescani i quali si erano integrati, in fondo
tradendo l'insegnamento del loro fondatore Francesco d'Assisi, nei
meccanismi potere-ricchezza della chiesa di Roma), e le forme della
predicazione ottengono via via un enorme successo e adesione
popolare, al punto che la gente abbandona i riti cattolici per
affluire in massa alle "prediche" degli Apostolici.
Gherardino invia anche diversi Apostolici a portare il proprio
messaggio in terre lontane. Questo enorme successo (riconosciuto
dalle più autorevoli fonti storiografiche cattoliche dell'epoca) non
può più essere tollerato dalla chiesa romana: il mite Gherardino
(pacifista integrale) viene imprigionato, alcuni apostolici vengono
messi al rogo, e infine, nel 1300, Gherardino stesso viene arso vivo
sulla pubblica piazza, nel nome del Signore. Ma il rogo di Gherardino
Segalello, anziché spegnere il movimento apostolico, per uno di
quegli strani "scherzi" della storia, segna invece l'inizio
di una vicenda del tutto originale, e di enorme portata, nel medioevo
italiano. Tra i molti che erano venuti in Emilia anche da lontano per
partecipare al movimento apostolico, vi è Dolcino, nativo di Prato
Sesia (Novara). Dopo la morte del fondatore, Dolcino di fatto assume
il ruolo di leader del movimento, il cui nucleo "dirigente",
sotto la pressione dell'Inquisizione, si sposta nel 1300 dall'Emilia
al Trentino (vengono chiamati qui ed accolti da loro amici e
compagni). La repressione tuttavia li segue anche lì, ove tre
apostolici (due uomini e una donna) vengono posti al rogo. Nel
1303/1304 ecco allora Dolcino, con il gruppo degli Apostolici più
fedeli (uomini, donne, vecchi e bambini), partire nel lungo viaggio
che li porterà, attraverso le montagne lombarde (presso Chiavenna vi
è tuttora un paese che si chiama Campodolcino) in Valsesia. La
Valsesia è la terra d'origine di Dolcino, qui egli conta amici, ed è
naturale che, per salvarsi, egli pensi a questa meta. Tra le donne
che fanno parte di questo gruppo vi è la bellissima Margherita di
Trento, di nobili origini, compagna di Dolcino.
La
Valsesia era, però, da molto tempo in lotta aperta prima contro i
grandi feudatari (conti di Biandrate), poi contro i comuni della
pianura (Novara e Vercelli). Quando il gruppo degli Apostolici giunge
a Gattinara e Serravalle, centri nella parte bassa della valle, e qui
ricomincia la propria predicazione per una chiesa ed una società
nuove, l'accoglienza popolare è entusiastica. I vescovi di Vercelli
e Novara, in accordo con il papa, vedendo come l'avvento degli
apostolici fa da catalizzatore per le istanze autonomiste delle
popolazioni valsesiane, bandiscono allora una vera e propria crociata
per debellarli. Viene reclutato un vero e proprio esercito
professionale (anche i balestrieri genovesi, abilissimi nel tiro) per
farla finita una volta per tutte. Gli Apostolici, questa volta, uniti
ai valsesiani ribelli, decidono di difendersi. Nel 1304 inizia dunque
una vera e propria guerra di guerriglia tra un esercito cristiano e
cristiani che credono in una chiesa diversa ed alternativa. Si
susseguono scontri e battaglie, nelle quali Dolcino dà anche prova
di notevole intelligenza militare. I ribelli si spingono in alto
nella valle e, sul monte chiamato Parete Calva, che è ideale per la
difesa, si installano con l'appoggio dei montanari fondando una vera
e propria "comune" eretica, in attesa di quello sbocco
finale che Dolcino, uomo colto, teologo e filosofo della storia,
ritiene imminente. I crociati assediano la Parete Calva, ove sono
asserragliati i ribelli (alcune fonti parlano di 4000 persone, altre
di 1.400), e si susseguono scontri sanguinosi. L'inverno, per i
rivoltosi, è terribile. Essi vivono in condizioni ormai disperate.
Finché, guidati da Margherita in un difficile passaggio tra metri di
neve (ancora oggi quel luogo si chiama "Varco della Monaca"),
riescono a devallare portandosi nel Biellese. Qui essi si fortificano
sul Monte da allora chiamato Monte dei Ribelli, o Rubello. Ma i
crociati si riorganizzano e procedono ad un nuovo assedio. I ribelli
sono allo stremo, e alla fine l'ultimo assalto provoca una
carneficina: circa 800 ribelli sono trucidati sul posto, mentre
Dolcino, Margherita e Longino Cattaneo (luogotenente di Dolcino) sono
catturati vivi. Margherita e Longino verranno posti al rogo in
Biella. Margherita rifiuterà di abiurare, respingerà le proposte di
matrimonio di alcuni nobili locali, che l'avrebbero salvata dal rogo,
e sceglierà di restare fedele al suo ideale e al suo compagno fino
in fondo. Dolcino prima dovrà assistere al supplizio della sua donna
e poi, a Vercelli, verrà condotto al rogo si di un carro. Durante il
tragitto viene torturato con tenaglie ardenti, ma tutti i
commentatori sono concordi nell'attribuirgli un coraggio
straordinario: non si lamenta mai, ma solo si stringe nelle spalle
quando gli viene amputato il naso e trae un sospiro quando viene
evirato. Infine, nel 1307, anche per lui la "giustizia" di
Dio significa il rogo. Tre anni di resistenza armata nel nome di
Cristo si concludono tra quelle fiamme, ma altri dolciniani un po' da
ogni parte continueranno ad esistere: si hanno notizie fino al 1374.
Di più, Dolcino, Margherita e gli Apostolici diverranno simboli di
libertà ed emancipazione fino ai giorni nostri, e la memoria
popolare
non li dimenticherà. Addirittura nel 1907 (sesto centenario del
martirio) vi saranno celebrazioni di enorme rilievo con
l'edificazione di un obelisco alto 12 metri proprio sui luoghi della
loro ultima resistenza.
Tavo Burat
Dolcino, civiltà montanara e autonomia
bioregionale
Atti del convegno Dolcino, Storia, Pensiero,
Messaggio. Varallo Sesia 4 novembre 2006
P er
"bioregione" si intende un luogo geografico riconoscibile
per le sue caratteristiche di suolo, di specie animali e vegetali, di
microclima, oltre che per la cultura umana che da tempo immemorabile
si è sviluppata in armonia con tutto ciò. Le Valli alpine, come la
Valle Sesia, costituiscono - o meglio, costituivano - bioregioni, e
cioè insieme biologici tendenti all'autosufficienza ed
all'autoproduttività, che si sono adattati alle condizioni dei loro
habitat dove si realizza un "equilibrio circolare" tra
tutti i fattori (produttori di energia, consumatori di energia,
eliminatori dei rifiuti). Le popolazioni inserite nella bioregione
formano comunità locali conferenti veste concreta a quello spirito
di Gemeinchaft,
cioè di "comunità di destino" entro cui si esprimono
secoli di produzione culturale,
in spazi per lo più liberi dai condizionamenti, affrancati dalla
subalternità, caratterizzati da una produzione culturale autonoma e
cioè non eterodiretta.
er
"bioregione" si intende un luogo geografico riconoscibile
per le sue caratteristiche di suolo, di specie animali e vegetali, di
microclima, oltre che per la cultura umana che da tempo immemorabile
si è sviluppata in armonia con tutto ciò. Le Valli alpine, come la
Valle Sesia, costituiscono - o meglio, costituivano - bioregioni, e
cioè insieme biologici tendenti all'autosufficienza ed
all'autoproduttività, che si sono adattati alle condizioni dei loro
habitat dove si realizza un "equilibrio circolare" tra
tutti i fattori (produttori di energia, consumatori di energia,
eliminatori dei rifiuti). Le popolazioni inserite nella bioregione
formano comunità locali conferenti veste concreta a quello spirito
di Gemeinchaft,
cioè di "comunità di destino" entro cui si esprimono
secoli di produzione culturale,
in spazi per lo più liberi dai condizionamenti, affrancati dalla
subalternità, caratterizzati da una produzione culturale autonoma e
cioè non eterodiretta.
Orbene,
a me sembra che per comprendere Dolcino, Margherita e la loro
relazione con la Valle Sesia, sia necessario rapportarli alla
bioregione teatro della epopea del 1305-1307. Quella Valle Sesia che,
con il trattato di Gozzano del 1275, aveva conquistato con decenni di
guerriglia contro i feudatari Biandrate prima e i centri
metropolitani di Vercelli e Novara poi, una quasi indipendenza;
"quasi" perché I 'Universitas valsesiana corrispondeva -
utilizzando un termine moderno - ad un protettorato: infatti, per
trattati e contese con potenze forestiere era pur sempre necessario
l'assenso della città (Novara).
Come
è stato puntualmente rilevato,
il rastrellamento per la caccia agli eretici, scatenato dai bravacci
vescovili, con la conseguente sventura delle razzie operate da truppe
assoldate che, com'era in
uso, dovevano approvvigionarsi con le risorse locali, depredando i
poveri montanari, invisi perché sospettati inoltre di proteggere gli
eretici; le rappresaglie con l'abbattimento e l'incendio degli
abituri rustici (quanto avverrà in quegli stessi luoghi 640 anni
dopo, farà dire nihil
sub soli novum!), non
potevano che provocare una rabbiosa reazione da parte dei locali che,
in quelle incursioni pre-potenti, vedevano a buon titolo una aperta
violazione, e quindi una inaccettabile offesa, ai patti sottoscritti
a Gozzano. Fondamentale è comprendere la struttura delle comunità
alpine che caratterizzavano ancora le alti valli quando ospitarono
gli Apostolici di Dolcino. Si trattava di vere comunità reali, non
personali, caratterizzate dalla coesistenza fra la proprietà privata
e quella collettiva. La prima era limitata alla abitazione, alle
armi, agli utensili da lavoro, al bestiame ed a poca terra; la grande
proprietà - i campi coltivabili, le brughiere e gli alpeggi per i
pascoli, i boschi - era comunitaria, e il godimento delle sue singole
componenti era stabilito da "regole" scaturite da assemblee
di uomini liberi, vale a dire da coloro che portavano le armi e che
al prezzo della vita difendevano quella proprietà.
In
alcuni Cantoni della Svizzera primitiva si è conservata la
Landsgemeinde,
assemblea per gli affari comunali e cantonali che emana leggi e
regolamenti secondo i dettami della democrazia diretta, e la
partecipazione è un diritto-dovere riservato sino a non molti anni
fa agli uomini atti alle armi. Le comunità longobarde diedero vigore
a tali assemblee degli uomini liberi, gli arimanni. Queste comunità
erano chiamate vicìnie
(vicinanze
nel Biellese) comunaglie
nell' Appennino parmense, regole,
appunto, nel Cadore e nel Veneto. L'etica che informava lo spirito
comunitario sull'inalienabilità del suolo, era di voler conservare
intatto il patrimonio collettivo; quest'etica venne minata e
distrutta dall'introduzione del diritto bizantino cristianizzato,
codificato dall'imperatore Giustiniano, che sarà la base del Diritto
Romano, dal quale si attingerà a piene mani per dotare il nuovo
Stato unitario italiano del 1861. La comunità rurale-alpina può
quindi definirsi come un insieme di famiglie vicine
che coltivano un dato territorio soggetto a regole
di utilizzazione collettiva, ed è l'antenata della maggior parte
degli odierni Comuni "politici": in Svizzera sussiste
tuttora il "doppio comune": quello moderno, "politico",
e quello detto, in Canton Ticino e nei Grigioni italiani,
"patriziale" corrispondente alla nostra "vicìnia"
competente per l'amministrazione dei beni comunitari e per gli
"affari pauperili" (cioè, l'assistenza);
sino al secolo XIX ci furono conflitti anche aspri di competenza tra
consigli "politici" e "patriziali" (in cui gli
elettori sono esclusivamente gli "autoctoni", e cioè gli
appartenenti a famiglie riconosciute originarie del luogo). Queste
assemblee discutevano la priorità delle coltivazioni, le rotazioni
agronomiche, lo sfruttamento dei boschi e dei diritti comunitari sul
legnatico, di caccia e di pesca, dibattevano sull'ammissione di
forestieri: così avvenne per gli Apostolici di Dolcino, come
sappiamo dell'invito di Milano Sola ad ospitarli a Campertogno; o sul
loro rigetto, come avvenne invece per le truppe di repressione
inviate in alta Valle a caccia degli "eretici". La
sostituzione del diritto tribale, poi longobardo, con il Diritto
Romano non fu certo "pacifica" e durò secoli. In molte
alti valli, quegli "uomini liberi" poterono conservare con
le armi i loro privilegi, cioè la loro autonomia, le loro "regole";
le vicìnie
riuscirono a sopravvivere specialmente sulle montagne (divennero i
cosiddetti "usi civici") e si conservarono sino all'inizio
del secolo XIX; in Valsesia, ricordiamo la strenua battaglia
autonomista dell' on. Aurelio Turcotti (Varallo 1808 Torino 1885)
canonico, ma poi fieramente eretico che manifestò nei suoi scritti
simpatia per Dolcino, al Parlamento subalpino
nei banchi della "montagna", la sinistra in cui sedeva
Angelo Brofferio.
Per
le alti valli di cui stiamo parlando, possiamo rilevare che la
tradizione culturale formatasi durante l'età finale del bronzo e del
ferro, sta tramontando soltanto con i nostri nonni o addirittura con
i nostri padri (la prima Guerra Mondiale può essere considerata lo
iato), come dimostra lo studio delle tradizioni popolari che hanno
tramandato sino ad oggi antichissime ritualità.
Oltre
alla vicìnia,
esisteva un'altra organizzazione comunitaria, la cui importanza è
sfuggita agli studiosi di Diritto italiano, in quanto nelle
documentazioni comunali se ne trovano soltanto labili tracce molto
frammentarie: si tratta di quella che era chiamata (in Piemonte, ma
non solo) la Badia,
o Abbadia:
corporazione che in origine riuniva i giovani dal comune periodo di
"spupillamento", gelosa custode delle ataviche libertà e
della "cultura" orale alternativa: lo stesso nome di
"Abbadia"
appare come una sfida alla cultura ufficiale, "scritta",
quella codificata nelle Abbazie del monachesimo medievale. Le "Badie"
strenuamente difendevano i più remoti ordinamenti e costumi
comunitari, tramandati nelle feste stagionali, quali i carnevali ed i
maggi, e furono alla base del tuchinaggio. Le competenze stesse di
queste corporazioni, ovvero l'organizzazione della vita comunitaria,
delle antiche regole, delle feste, della difesa del territorio e dei
suoi confini, divengono quindi eredità vivente e ragione storica
delle insorgenze montanare e contadine del Piemonte. Infatti, tutte
le insurrezioni e le rivolte contadine mirarono a ristabilire norme e
valori infranti nel passato.
I "coscritti" ed i "comitati" per il Carnevale, i
grandi pasti comunitari (fagiolate, polentate, risotti ecc.) sono
"reliquie" delle Badie; molte di esse furono cattolicizzate
e divennero confraternite (alcune tuttora armate, come quella di
Barbania nel Canavese): i capi, gli abà,
si trasformarono in "priori" o addirittura santificati:
Euseo, strano santo valsesiano di cui si racconta che morì per la
vergogna di essere stato costretto dai giovani ad indossare abiti
carnevaleschi, fu con ogni probabilità un abà;
il suo santuario è eretto su un masso erratico, all'imbocco della
Valsesia, e colà vi è una grande coppella nella roccia, che
raccoglie l'acqua piovana e che funge da terapeutica acquasantiera. E
così, io sono convinto che Milano Sola, il "ricco contadino"
di Campertogno (ma si poteva essere "ricchi contadini"
nell'agricoltura di sopravvivenza che caratterizzava la località
agli inizi del XIV secolo?), che "invitò" Dolcino ed i
suoi in alta Valle, altri non era se non un abà,
un autorevole capo dei giovani di Campertogno alle armi, che
manifestò l'invito decretato, come era negli usi, dalla assemblea
della vicìnia.
La funzione delle Badie nelle insorgenze rustiche, apparirà
macroscopicamente nel tuchinaggio, iniziato in Occitania, nel
Massiccio Centrale, a seguito della predicazione di un francescano
dissidente, Jean de la Rocquetaillade, cinquant'anni circa dopo il
rogo di Dolcino e di Margherita; ripreso nel Biellese con la cattura
del vescovo da parte dei giovani del Piazzo nel 1377, nel Canavese
dal 1380 alla metà del XVI secolo.
Come
abbiamo più volte sostenuto, la comunità cristiana che Dolcino ed i
suoi seguaci proponevano come preconitrice del "Regno" era
del tutto speculare, omologa, a quella dei montanari specie dell'alta
valle non soggetta alle influenze mercantili della pianura: infatti
vi si riscontrano i medesimi valori fondamentali: solidarietà e
fratellanza, comunione dei beni, rifiuto di ogni tipo di balzello
(taglie, o decime che fossero), parità uomo-donna, nessun servo
nessun padrone, ma Dio unico "Signore"; rifiuto del denaro
(si pensi al fondatore del movimento Apostolico, predecessore di
Dolcino, quel Gherardino Segalello, "libertario di Dio" che
gettò via i denari, francescano anarchico, salito al rogo l'anno
1300 a Parma) poiché l'economia era fondata sul servizio comunitario
e sul baratto... Dolcino testimoniava nel messaggio evangelico
radicale la validità dell'ordinamento giuridico alpino,
rivitalizzato dai Longobardi e minacciato dal Diritto Romano che
montava dai centri urbani della pianura. La "crociata",
invece, era la messa in opera di uno strumento oppressivo per
l'affermazione dei princìpi antitetici: gerarchia; privilegi
riconosciuti ai Signori feudali, laici o ecclesiastici che fossero;
la donna considerata veicolo diabolico; la moneta sonante, anziché
il libero scambio.
La
sconfitta di Dolcino segnerà l'inizio della fine della civiltà
alpina: alla luce del sole rimarrà l'ordinamento giuridico latino;
ai "resistenti" resterà il buio dei boschi e della notte,
dove troveranno rifugio i banditi; le donne "vestali"
dell'antica cultura agreste diventeranno "streghe". Le fate
giovani e belle saranno tramutate dalla cultura vincente in vecchie
malefiche megere. La pratica del libero scambio in sfida alla legge
sarà dei contrabbandieri.
Le
alte valli alpine presenteranno nella loro decadenza economica,
politica e sociale tutti i caratteri delle colonie, così come
appaiono nel Terzo Mondo:
le materie prime prodotte (si pensi ai metalli, cominciando dall'oro,
ma anche all'acqua, bene quanto mai prezioso), sono consumate e
trasformate nelle metropoli; le popolazioni sono territorialmente
divise con confini estranei alla loro realtà economica sociale (le
etnie alpine sono le medesime nei due versanti: provenzali o
occitani, francoprovenzali, walser, retoromanci o ladini, tirolesi,
carinziani, sloveni, .. ); le valli costituiscono una grande riserva
di mano d'opera (serve, e poi operai) e di buoni soldati; il sistema
viario di comunicazione da orizzontale tra valle e valle, sostituito
da quello a raggiera che parte dai centri metropolitani per
facilitare la pianurizzazione delle attività economiche; il capitale
locale sparito, è sostituito da quello dei metropolitani, che a
poco a poco si impadroniscono della terra (turismo speculativo che
espelle gli indigeni); la produzione agricola, artigianale,
soppiantata da quella industriale metropolitana; gli indigeni
considerati culturalmente alienati, minus
habentes e gli idiomi
che esprimono la loro cultura bistrattata, degradati da valore
"lingua" a "minus-valore" dialetto, da estirpare
e buttare (la rapina del minus-valore, dopo quella del plus-valore!).
Economia,
cultura e lingua delle élites
metropolitane si impongono sempre più nelle periferie: quanto è
"alternativo", resistente alla globalizzazione, viene via
via sospinto ai margini, o buttato a mare (come avvenuto nelle aree
celtiche: in Scozia, Galles, Irlanda; Bretagna e per quella occitana,
in Francia) dalla potenza economica metropolitana (di Londra o
Parigi);
da noi la "resistenza" è compressa contro le montagne,
nelle Valli, sempre più in alto. Laddove i popoli indigeni non
concordano con i piani elaborati dalle élites, che mistificano il
proprio interesse facendolo apparire "progresso" tout
court, essi possono essere sempre rappresentati quali terroristi
pericolosi, primitivi, gretti egoisti, ostacolo allo sviluppo.
E' l'inversione dell' etica: colto, aperto e positivo il "cittadino";
ignorante e rozzo, testardo
e meritevole al più di "conversione" di "emancipazione",
quando non di severa condanna, il montanaro, "villano"
insomma: un "eretico", cui un tempo spettava l'abitello
giallo o il rogo, ed oggi il disprezzo sociale del benpensantismo
cittadino. E' l'antica favola del lupo a monte e del povero agnello a
valle, colpevole di aver intorbidito l'acqua ...
Così
Dolcino appare, emblematicamente, mitico eroe di una civiltà alpina
che "resiste". Un personaggio maestoso e tragico, come i
protagonisti dei romanzi del maggior scrittore svizzero di
espressione francese, Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947), proprio
come Dolcino, in presa col destino o con le forze di una natura
ostile, eroi simili a quelli della tragedia greca che guardano il
volto misterioso del fato, cui non possono resistere; dovranno
cedere, saranno sbalzati fuori dalla vita ma, lottando, fedeli alla
loro passione, anche se soccombono, conservano una loro grande
dignità. Penso soprattutto al protagonista di un suo importante
romanzo, Farinet
, montanaro reale, fuorilegge valdostano diventato nel Canton Vallese
un mito al quale il paese di Saillon, teatro delle sue gesta sino
alla morte nel 1880, quando la gendarmeria gli diede una caccia
spietata (come fosse un orso od un lupo) gli ha dedicato la piazza
principale, un monumento, un'affascinante passerella sul precipizio
dove fu trovato cadavere, una sequela di vetrate lungo il sentiero
che conduce ad una simbolica e minuscola vigna, luogo di meditazione
per tutti coloro che cercano libertà, pace e giustizia. Purtroppo
Do1cino non avrà l'entusiastico e corale riscatto tributato a
Farinet, e mai i luoghi teatro della sua vicenda epica, Prato,
Varallo, Campertogno, Rassa, Trivero ... potranno rivaleggiare con
Saillon. Do1cino ha avuto il torto di sfidare non gli interessi
metropolitani confederali (Farinet coniava moneta in concorrenza con
la zecca di Berna!), ma di ribellarsi in Italia alla Chiesa Cattolica
Romana: bollato come eretico, e sanguinario bandito, ha patito per
sette secoli calunnie e diffamazioni spietate. Tuttavia, chi, come
Ramuz, ha saputo interpretare la civiltà alpina, ha ben colto il
valore della sua figura emblematica: lo scrittore friulano Carlo
Sgorlon, in un romanzo racconta "la
moderna e sempre valida favola delle prevaricazioni dell'uomo sulla
natura; favola antica della dabbenaggine e del miraggio del progresso
che, alleati contro l'equilibrio della creazione, scatenano il sangue
ferito della terra. Perché uccidono il passato, scambiandolo per
passatismo, in nome di un avvenire che è furto, sconsacrazione,
improvvisata padronanza del fuoco degli déi".
In questo libro si staglia la figura di Siro, un montanaro contrario
alla strada e alla diga progettata ed in fase di realizzo: il romanzo
è ispirato alla tragedia del Vajont anche se i toponimi sono mutati.
A chi diceva a Siro; "sei
tu fuori dal tempo. Dov'è il pericolo? Nei lavori della strada?"
replicava: "ma
certo. Cominciano sempre con una strada. Se lasciate che la strada si
faccia, poi sarà tardi per ogni cosa". Lui conosceva le loro
tecniche, le aveva viste applicate in molte altre valli. Dopo la
strada veniva gente che avrebbe messo le mani ingorde su ogni cosa.
Avrebbe sventrato i boschi per farne da sci, costruito ogni possibile
diavoleria, seggiovie, impianti di risalita, funivie per salire in
cima alla montagna senza muovere un solo passo; avrebbe fabbricato
alberghi, rovinato i nevai del massiccio, e le valli e le montagne
sarebbero state percorse da una ragnatela di fili di acciaio e di
piloni di cemento. Avrebbero deviato le acque... "Le acque? Cosa
c'entrano le acque?" Non lo so. Dico per dire. So soltanto che
rovinano tutto. "Siro, ragiona. La gente della
valle aspetta da decenni che la strada sia fatta". Ma lui non
voleva ragionare. Era sconvolto dalla sua passione, e continuava a
dire che bisognava fare una lega di tutta la gente per bloccare il
progetto che ci minacciava, correre in tutti i paesi a soffiare con
ogni forza dentro l'antico corno di bue, per gettare l'allarme. Lo
guardai negli occhi e ebbi l'impressione che non mi vedesse nemmeno.
Mi sembra una sorta di eretico d'altri tempi. Un fra Dolcino uscito
dai secoli remoti ed entrato chissà come nel nostro tempo di motori
e di macchine. Non si era accorto che quell'epoca era finita, che il
frate di Novara e la sua donna dai capelli rossi erano stati bruciati
vivi, e la sua gente massacrata e dispersa. Si era perduto un grande
sogno, quello delle antiche comunità montanare. Ma adesso i tempi
erano cambiati, e sopravviveva soltanto un suo pallido fantasma nel
fatto che la gente affamata andava a far legna nell'antico bosco
demaniale. Tutto il resto era cambiato. Oggi i grandi feudatari
esistevano sotto forma di banche e società finanziarie, le quali
potevano anche riuscire in quello che era stato impossibile ai
vescovi medievali. L'avrebbero fatto anche qui, e anzi avevano già
cominciato a farlo, ma opporsi era una illusione mitica e fuori dal
tempo.
Ramuz
e Sgorlon ci spiegano così, sia pure molto indirettamente, perché
il movimento contro il Treno Alta Velocità -TAV- in Valle Susa abbia
emblematicamente "recuperato" fra Dolcino: è la seconda
volta, dopo gli anni di fine - principio secolo, quando il movimento
operaio Valsesiano e Biellese onorò il "precursore", che
un movimento popolare riscopre Dolcino e lo rivendica. In Valle Susa,
e in internet circola una significante lettera, firmata "Dolcino
e Margherita, da nessun luogo" (utopia!) che è un inno alla
libertà della montagna, una strenua difesa di quella "bioregione"
che una colossale strada ferrata vorrebbe ancor più sconvolgere.
Una valle già
percorsa da autostrade, superstrade e ferrovia, sconquassata da una
"grande opera" che prevede montagne scavate per quindici
anni, con un milione di metri cubi di materiale pericoloso da
trasportare da qualche parte; cinquecento camion in transito giorno e
notte nella valle per trasportare i detriti scavati; tonnellate di
polvere circolante nell'aria: le verifiche secondo le quali non ci
sarebbe amianto nei terreni si sono rivelate inattendibili, il
movimento "No Tav" ne ha portato alla luce le lacune dal
punto di vista scientifico e la Procura di Torino ha aperto un'
inchiesta. Si estende la desolazione di panorami cementificati, la
distruzione di prati, l'ombra di viadotti, il grigio delle decine di
piloni di cemento, antenne e tralicci aumentati in modo esponenziale,
inoltre le falde deviate e prosciugate, le acque inquinate. Ma
l'opera che costa miliardi e miliardi di curo non solo è dannosa, ma
inutile, perché il rapporto tra trasporto merci e Pil cresce fino a
quando lo sviluppo economico di un Paese non raggiunge una certa
soglia, dopo la quale si stabilizza e decresce: i dati europei
Eurostat evidenziano come in Europa il rapporto tra tonnellate per km
di merci (indicatore di qualità di trasporto delle merci) e PiI, tra
il 1997 e il 2002, è rimasto invariato; per l'Italia è
stazionario.
II movimento che ha riconosciuto in Dolcino un emblema,
antepone la tutela delle bioregione e della salute agli interessi di
coloro che Sgorlon chiamava i "nuovi feudatari", cioè
poche ma potenti lobby economiche, spesso trasversali negli
schieramenti politici.
In
realtà, si confonde il "progresso", che è liberazione dal
bisogno e dal servaggio, con lo "sviluppo" che non deve
essere infinito e che è destinato a schiantarsi a grande velocità
contro la barriera del limite ecologico. Si sostiene che la TAV è
indispensabile, altrimenti l'Italia non si modernizza, ma senza
fondarsi su dati e fatti nazionali. E Luciano Gallino
si chiede se non siano proprio gli abitanti della Val Susa a fare,
invece, il vero interesse nazionale, e che stiano spronandoci a
pensare se è davvero conveniente trasformare l'Italia nella
piattaforma logistica d'Europa, e se la perseveranza di realizzare la
TAV senza valide ragioni sia conseguenza dell'incapacità di
esplorare in modo corretto altre opportunità di cui disponiamo.
Forse
questi Dolcino e Margherita strenui difensori della bioregione
alpina, e cioè di una regione-comunità in osmosi con il territorio,
sono trascendentali, più attinenti ai personaggi mitici,
tramandatici dalla tradizione popolare, che a quelli storici. Da
Robin Hood a Farinet, la leggenda sembra consegnarci, meglio dei
documenti, una realtà più significante, certamente più
coinvolgente e affascinante. Andrè Malraux
lasciò scritto:
“solo il leggendario
è vero” Prima di
lui, Beaudelaire aveva esclamato: “Sei
sicuro che questa leggenda sia proprio vera? Ma che m’importa, se
mi ha aiutato a vivere!”. E
Alessandro Dumas va ancora oltre:
“Si può violare la storia, purché ci faccia un bel figlio!”.
Dolcino
e Margherita, furono torturati atrocemente ed arsi il 1° giugno
1307. Malgrado sei secoli di demonizzazione, il movimento operaio li
riconobbe precursori della lotta per il riscatto degli oppressi, ed a
Dolcino innalzò sul monte Massaro un obelisco alto 11 metri,
abbattuto vent' anni dopo, nel 1927 , dal regime fascista. Ancora una
volta si credeva di averla "fatta finita" con siffatti
simboli scomodi. Il bisettimanale della curia scrisse allora che
"quel povero
cumulo di pietre aveva cessato di essere, come si augurò e si
credette dai promotori, un faro ed un punto di riferimento
" Ma non fu cosi: nel 1974, l'anno in cui il pensiero laico
trionfò respingendo con un referendum la proposta di abrogare la
legge che introduceva il divorzio nell'ordinamento giuridico
italiano, sui ruderi di quell'obelisco sorse un cippo. Oggi Dolcino e
Margherita fanno sentire le loro voce "altra", come eroi
dell'autonomia e della salvaguardia delle bioregione. Per dirla con
Giuseppe Giusti, "dopo morti sono più vivi di prima".
LONGINO CATTANEO ed il
MOVIMENTO DOLCINIANO 700 ANNI DOPO
A cura di Tavo
Burat
Alla
morte di Francesco d’Assisi (1226) nell’Ordine da lui fondato si
delineano due correnti,
quella dei Conventuali che accettano le donazioni e la vita nel
convento, e quella degli Spirituali che si ispirano alle profezie di
Gioachino da Fiore (†
1202), e vedono in Francesco l’inizio della nuova era dello
Spirito, e vivono nomadi in povertà. In linea diretta dal
francescanesimo discendono gli apostolici, un “ordine” di
militanti analoghi ai “perfetti”
del Catarismo, con una vasta rete di simpatizzanti e di
collaboratori, così da poter essere modernamente definito
“movimento”
fondati nel 1260 da Gherardino Segalello da Ozzano Taro (Parma), che
possiamo definire “libertario
di Dio”.
Con i suoi sermoni e la sua vita, e le sue recite da “mistero
buffo”,
egli testimonia l’apostolicità proponendo il ritorno alla prassi
cristiana primitiva, svincolata da ricchezza e da potere,
egualitaria, e la comunione dei beni secondo gli Atti degli Apostoli.
Per questo, per far ridere con i suoi monologhi e quindi per
“irridere”
al potere feudale, fra Gherardino è arso al rogo il 18 Luglio 1300,
sulla riva del torrente Parma, l’anno del primo Giubileo, festa del
perdono, indetta da Papa Bonifacio VIII. Tra coloro che assistono al
rogo di frà Gherardo è anche un giovane discepolo: Dolcino, nativo
di Trontano in val d’Ossola secondo alcune fonti o, secondo altre e
dalle ricerche più recenti, a Prato Sesia; probabilmente dalla
famiglie Preti o De Pretis, ghibellini imparentati con i
Tornelli,parimenti ghibellini valsesiani.
Un
mese dopo il rogo di Gherardo, Dolcino, nell’agosto 1300, scrive la
sua prima lettera
“ad
fideles”.
Questa lettera
costituisce il primo manifesto ufficiale del movimento e la
presentazione di Dolcino quale guida profetica ed illuminata. Egli
rivela qui una impostazione gioachimita, non priva però di apporti
originali. Il discorso, da penitenziale evangelico, qual era quello
del Segalello ( poenitentiàgite
era il mantra
del fondatore degli
Apostolici, nel senso di spronare a costruire un nuovo mondo, della
carità e del pentimento) diviene teologico; una vera “enciclica”
che poggia, intelligentemente, oltre che su basi dottrinali, su di un
diffuso stato d’animo e sulla partecipazione agli avvenimenti
politici.
La
Chiesa romana, irrimediabilmente corrotta, non è più riformabile,
crollerà; la sua gerarchia sarà travolta, ed il nuovo imperatore,
un “novello Federico” sarà lo strumento dell’ira divina.
La
Chiesa abbandonerà ogni bene terreno, sceglierà definitivamente la
povertà ed inizierà così l’era dello Spirito, che durerà sino
alla fine dei giorni.
Questa
lettera ha immediatamente un grande successo. Poco dopo l’agosto
1300, Dolcino, predica e presiede incontri clandestini nel Trentino
Cìmego, dove si era rifugiato e dove era attivo un gruppo di
apostolici guidato dal fabbro frà Alberto; ma ritorna anche al
contado bolognese.
Da
Cìmego, nel dicembre 1303, scrive la sua seconda lettera-enciclica
con la quale rassicura i fedeli circa la vitalità del movimento, che
da libertario si trasforma in quello che oggi diremmo un “partito”,
con un organigramma ed un’organizzazione capillare nelle campagne e
nelle città.
Dolcino
ufficializza i responsabili : a capo di tutti gli appartenenti alla
congregazione apostolica è egli stesso, Dolcino novarese; quindi,
fra tutti dilettissima, la sorella Margherita e frate Longino da
Bergamo; seguono
poi tra i più autorevoli frà Federico da Novara ( altrove viene
detto “Grampa”,
che è una frazione di Mollia, in alta Val Sesia), frà Alberto
trentino e frà Valderico da Brescia(altrove precisato da
Toscolano).(1) Un altro passo fondamentale della fonte sulla vicenda
dolciniana (2) ci precisa che trattasi di “Longino
da Bergamo”
della famiglia dei Cattanei da Fedo o da Sacco : dopo Dolcino e
Margherita è l’apostolico di maggior rilievo,designato
immediatamente dopo i due capi : quindi il massimo discepolo, e
luogotenente e braccio destro dell’eresiarca. Dai processi
bolognesi, sappiamo che tra diversi Apostolici era d’uso far
parlare il più autorevole: il pur celebre Zaccaria di S. Agata (
Apostolico emiliano sin dal 1290, inquisito nel 1299 poi condannato
il 17 dicembre 1303 e
arso sul rogo il medesimo giorno in Campo
fori) dava la
precedenza a Dolcino ed a Longino, ascoltandoli.
Nel
1301-1302 è testimoniata la presenza da Longino da Bergamo nel
contado bolognese. Successivamente lo si troverà nel Trentino ed in
Piemonte sempre a fianco di Dolcino, di cui è il principale
discepolo, luogotenente e braccio destro, seguendolo sino all’ultimo
giorno(3).
Purtroppo,
oltre alle fonti citate ( la Historia
dell’Anonimo
sincrono ed i Processi), non si hanno altre notizie su frà Longino;
Arnaldo Segarizzi che è stato il primo più attendibile e profondo
studioso delle fonti apostoliche, annota che di Longino “non
è dato trovare alcuna notizia, come gentilmente (lo) informa il
chiarissimo prof. Mazzi
“ (4)
Raniero
Orioli è incline a ritenere l’esistenza di un possibile legame tra
la famiglia capitanale bergamasca di Longino con la fazione
ghibellina dei Suardi, che in certi anni è la vera padrona della
città e che, per tutto il ‘300, è una delle quattro famiglie (
con i Borghi, i Rivola ed i Sangallo) che si contendono se non il
supremo potere, almeno il primato.
Sul
finire dell’estate del 1304, i Suardi ed i ghibellini, cacciati da
Bergamo, si erano rifugiati nel castello di Martinengo dove si reca
l’inquisitore di Pavia,Lanfranco da Bergamo, ( al quale
probabilmente si deve la condanna del 1300 del mite Gherardino
Segalello), per un infruttuoso tentativo di mediazione, e dove ha
notizia, nel febbraio del 1305, della presenza di Apostolici nel
castrum
, a quel tempo
assediato dalle forze guelfe; recatosi a Romano, dove intenta un
processo contro apostolos
malos torna
altre due volte a Martinengo, sempre per chiarire la faccenda delle
presenze apostoliche, e riesce persino a trovare alcune literas
prefecti
apostolorum
(5)
Nel
1302 sul Garda è stanziato il “
direttivo”
apostolico; ed è allora che Matteo Visconti, cacciato da Milano e
perso il dominio su Novara,in fuga da Oleggio,si dirige verso i laghi
di Garda e d’Iseo.
Sul
finire del Maggio 1304, Matteo ed i ghibellini comaschi fuoriusciti
cercano di riprendere Como. A Mendrisio, sulla strada di Lugano lungo
la quale erano scese direttamente a Como le armate viscontee,
troviamo l’apostolico valsesiano Federico Grampa ed altri
dolciniani.
Scatenatesi
le repressioni nel Trentino, dove a Cìmego vengono mandati al rogo
tre apostolici (un uomo e due donne, una delle quali è la moglie di
frà Alberto) i Dolciniani abbandonano la valle del Chiese: da
Bagolino ( dove recentemente è stata scoperta la presenza,
all’epoca, di varie famiglie aderenti alla setta) e dal passo di
Crocedomini entrano in Val Camonica e poi nel Bergamasco; tutto fa
pensare che siano transitati da Martinengo e che, colà, sia stata
decisa la salita in Val Sesia. Probabilmente fu proprio la presenza
del bergamasco Longino a facilitare il passaggio da Martinengo e
l’incontro con i ghibellini ivi asserragliati.
Le
connessioni e le compresenze tra gli Apostolici e i Visconti assieme
sul Garda nel 1302, a Como nel 1303 a Martinengo nel 1305 – fanno
supporre a Orioli (6) una connivenza tra gli eretici ed i ghibellini.
E’
presumibile che il partito ghibellino, e particolarmente i Visconti,
nel tentativo di riconquistare Milano, dove il potere era passato ai
guelfi (i Torriani), come nelle città satelliti di Vercelli, di
Novara e di Bergamo, intendesse strumentalizzare il movimento
apostolico per indebolire gli avversari ( secondo l’assioma per cui
i nemici dei miei nemici sono miei amici): la storia insegna come gli
estromessi dal potere facciano fronte comune contro i nuovi
detentori, e come a tal fine sia usato il malcontento, l’ira
popolare; basti pensare alla Vandea, al crollo delle repubbliche
giacobine in Italia, al “brigantaggio”
meridionale dopo la proclamazione del Regno d’Italia nel 1861.
Resta
comunque il fatto che gli Apostolici provenienti dal Trentino non
avevano alcuna velleità guerrigliera, altrimenti l’avrebbero già
manifestata resistendo alle persecuzioni nelle loro valli, dove si
sarebbero potuti meglio celare, giovandosi della conoscenza dei
luoghi e degli appoggi di familiari ed amici.
Comunque,
Raniero Orioli che, come abbiamo visto, suppone connessioni tra
Visconti e Dolciniani, i quali non sarebbero soltanto “eretici
ribelli contro la Chiesa di Roma, ma anche ghibellini contro la
coalizione guelfa di Lombardia”, ribadisce come “ la matrice
causale e determinante di tutta l’azione dolciniana non fosse –
non potesse essere – l’istanza o l’adesione politica, bensì la
fede e la tensione religiosa (7).
Dalla
Bergamasca Dolcino con i suoi passa nel Varesotto, e da qui a
Gattinara alle porte della Valsesia: un “ borgo franco” di
recentissima formazione, sorto per volontà del vescovo di Vercelli
al fine di controllare l’importante nodo stradale ( vi si
incrociano le strade per la Valsesia, il lago Maggiore e Novara,
Vercelli ed il Biellese).
Per
incentivare l’insediamento della popolazione, Gattinara ha avuto
particolari esenzioni fiscali: ma ciò diviene presto motivo di
conflitto con i feudatari Arborio e con il Vescovo.
Dolcino
giunge pertanto quando colà c’è un clima di tensione, ed è
quindi ben accolto in quanto notoriamente inviso all’autorità
religiosa. Così è pure ricevuto benevolmente nel borgo
immediatamente superiore, Serravalle Sesia, riuscendo anche ad
accattivarsi la simpatia del parroco locale. Si aggiunga che le forze
della lega guelfa, concentrate a Pavia ed a Piacenza, hanno sguarnito
momentaneamente di presidi militari la zona della media e bassa
Sesia.
Malgrado
i probabili incontri avuti con i ghibellini guidati da Matteo
Visconti e le “aderenze” vicine e lontane, le fonti ci dicono,
comunque, che Dolcino giunse nel 1305 a Gattinara “da lontani paesi
con alcuni seguaci”, e che subito “iniziò a predicare di
nascosto e subdolamente nei territori di Serravalle e dintorni, e
riuscì a sedurre con i suoi perversi insegnamenti numerosi uomini e
donne: atteggiamenti, questi, non certo di una masnada di
guerriglieri.
Dopo
circa quattro mesi, premuto dagli armati al soldo del Vescovo Ranieri
Avogadro di Vercelli, Dolcino si rifugia con i suoi nell’alta
valle, a Campertogno, invitatovi da un contadino, Milano Sola,
probabilmente un capo delle corporazioni giovanili, le “badie”,
che saranno poi protagoniste, nella seconda metà del medesimo XIV
secolo, delle insorgenze antifeudali (il “tuchinaggio”,
occitano e
piemontese).
Si
è preteso che contro Dolcino si fossero costituite delle “leghe”
valsesiane, ma gli statuti relativi sono oggi concordemente ritenuti
falsi grossolani. Invece i Valsesiani, già da secoli ribelli ai
feudatari ( i Biandrate) ed ai grossi Comuni della pianura, Vercelli
e Novara, che si contendevano il dominio della Valle, e usi alle armi
per la pratica della caccia, prendono le armi contro i rastrellamenti
compiuti dai bravacci vescovili che compiono razzie in Valle,
ritenendo, a buon titolo, i montanari solidali con gli “eretici”
perseguitati.
I
Valsesiani sono soprattutto gelosi della loro autonomia, ottenuta nel
1275 con il trattato di Gozzano, dai Comuni della pianura, Vercelli e
Novara, e pertanto sono insofferenti ad ogni prepotente intrusione
nella loro comunità alpina.
Dopo
alcuni mesi, non sentendosi sicuri a causa dei rastrellamenti,
Dolcino, Margherita, Longino ed i loro discepoli, e molti altri di
Campertogno, Quare e Rassa (8)
si trasferiscono
sulla cima delle Balme e poi, verso la fine dell’estate 1305, sulla
Parete Calva, luogo inespugnabile nella collaterale valle di Rassa.
Al
riparo dell’armata vescovile, i ribelli valsesiani guidati da
Dolcino, Margherita e Longino danno vita ad una guerriglia con azioni
improvvise, calando contro i nemici accampati in valle. Nei villaggi
danneggiano le chiese, ritenute “tempio
dei farisei”
nemici del Vangelo, collaborazionisti
degli invasori.; e le case dei magistrati del Vescovo-Conte. Uno dei
sequestrati è il podestà di Varallo, Brusati, nobile guelfo
novarese.
I
Vescovi di Vercelli e di Novara ingaggiano un corpo di balestrieri
genovesi, per contrastare i ribelli, abilissimi nel tiro con l’arco.
Costoro, costretti a rompere l’accerchiamento, non hanno che una
via di fuga laterale. Lasciati i compagni più deboli, i superstiti,
ridotti ormai a poche centinaia, nella notte tra il 9 ed il 10 Marzo
1306 abbandonano la Parete Calva ed iniziano una lunga marcia per
“grandi monti, nevi altissime, vie inesplorate e luoghi impervi”
come testualmente scrive l’anonimo Sincrono, principale fonte,
cattolica, di quegli avvenimenti, per giungere nel Biellese orientale
sul monte da allora chiamato “Rebelle o Rubello”e
cioè dei Ribelli, che essi fortificano.
Non
avendo viveri di scorta, i ribelli scendono su Trivero per
procurarseli dalle masserizie degli assedianti (il paese era stato
evacuato dai locali per togliere ogni appoggio ai resistenti).
Il
Vescovo di Vercelli, preoccupato dalla resistenza e dalle sconfitte
che avevano visto fallire i rastrellamenti in Valsesia, e che ora
subisce dalle sortite dei Dolciniani, ottiene che il nuovo Pontefice,
Clemente V, da Avignone bandisca ufficialmente una crociata contro i
demoniaci eretici. Per Dolcino ed i suoi nel dicembre 1306 inizia
l’ultimo inverno e la gran fame.
Dante
dà il quadro puntuale di Dolcino assediato sul Monte Ribello dalle
milizie vercellesi e novaresi, facendo dire a Maometto (canto XXVIII,
vv 54-60 dell’Inferno):
“Or
dì a frà Dolcin,dunque che s’armi
tu
che forse vedrai lo sole in breve,
s’egli
non vuol qui tosto seguitarmi,
sì
di vivande, che stretta di neve
non
rechi la vittoria al Novarese,
ch’altrimenti
acquistar non sarìa lieve”
Quasi
tutti e commentatori danteschi vedono qui una repressa simpatia per
Dolcino: infatti Dante vedeva nella Chiesa di Roma la “
prostituta”
dell’Apocalisse, da non confondersi con la vera Chiesa di Cristo,
che è il suo opposto. E’ poi indicativo che l’Apostolica sia
l’unica eresia citata dall’Alighieri nella sua “Commedia”
Finalmente,
il giovedì santo (giorno della cena del Signore) 1307, esattamente
un anno dopo l’insediamento sul monte Ribello, i crociati di
Vercelli e Novara sferrano l’attacco decisivo. La battaglia infuria
sulla piana di Stavello: ci vuole un’intera giornata perché molti
crociati riescano a travolgere pochi superstiti, uomini e donne
denutriti, ma che lottano nella convinzione che Dio li aiuterà.
E’
un macello: gran parte di quei disgraziati è massacrata e gettata in
un rio da allora chiamato Carnasco, le cui acque erano diventate
rosse come il sangue e rimarranno imbevibili per anni.
Dolcino,
Margherita e Longino Cattaneo sono catturati vivi, con loro altri 150
prigionieri, come riferisce l’Anonimo sincrono.
Dopo
la cattura, Dolcino, Margherita e Longino in catene sono portati
nelle prigioni di Biella Piazzo e poi a Vercelli, ove sono
orrendamente torturati, come minuziosamente ci narrano le fonti
cattoliche
(9).
Ogni
mezzo fu intrapreso, invano, affinchè abiurino la loro fede.
Margherita descritta come “bellissima”
rifiuta le proposte di matrimonio dei feudatari, che così
l’avrebbero salvata dal rogo.
I
corpi sanguinanti e sfigurati, ma ancora vivi, furono posti al rogo:
Dolcino a Vercelli alla confluenza del torrente Cervo con la Sesia
(punto difficile da identificare oggi, poiché l’orografia è
mutata), Longino Cattaneo sicuramente a Biella, nell’isolotto su
cui oggi poggia il ponte detto “della
Maddalena”
sul torrente Cervo; Margherita, secondo la tradizione popolare, in
quello stesso luogo. Tutti il 1° Giugno 1307.
Per
comprendere l’osmosi tra la popolazione locale valsesiana ed i
Dolciniani, è fondamentale evidenziare la struttura delle comunità
alpine che caratterizzavano ancora le alte valli agli inizi del XIV
secolo. Si trattava di comunità reali, non personali, contrassegnate
dalla coesistenza tra la proprietà privata e quella collettiva. La
prima era limitata all’abitazione, alle armi, agli utensili del
lavoro, al bestiame ed a poca terra; la grande proprietà – i campi
coltivabili, le brughiere e gli alpeggi per i pascoli, i boschi –
era comunitaria, e il godimento delle sue singole componenti era
stabilito da “regole”
scaturite da assemblee di uomini liberi, vale a dire da coloro che
portavano le armi e che al prezzo della vita difendevano quella
proprietà.
In
alcuni Cantoni della Svizzera primitiva si è conservata tuttora la
Landsgemeinde,
assemblea per gli affari comunali e cantonali che emana leggi e
regolamenti secondo i dettami della democrazia diretta, dove la
partecipazione è un diritto/dovere riservato, sino a non molti anni
fa agli uomini atti alle armi.
L’ordinamento
longobardo diede vigore a tali assemblee degli uomini liberi, gli
arimanni.
Queste
comunità erano chiamate vicinie
o vicinanze
in Piemonte e
Lombardia; comunaglie
nell’Appennino
parmense; regole,
appunto, nel Cadore e nel Veneto.
L’etica
che informava lo spirito comunitario, fondato sull’inalienabilità
del suolo, era quella di conservare intatto il patrimonio collettivo;
quest’etica venne minata e distrutta dall’introduzione del
diritto bizantino cristianizzato dall’imperatore Giustiniano, che
sarà la base del Diritto Romano, dal quale attingerà a piene mani
il nuovo Stato Unitario del 1861.
La
comunità rurale alpina può quindi definirsi come un insieme di
famiglie vicine
che coltivano un dato
territorio soggetto a
regole
di utilizzazione collettiva, ed è l’antenata della maggior parte
degli odierni Comuni “politici”.
In
Svizzera esiste tuttora il “doppio Comune“: quello moderno,
“politico”,
e quello detto, in Canton Ticino e nei Grigioni italiani,
“patriziale”
corrispondente alla
nostra “vicìnia “,
competente per l’amministrazione dei beni comunitari e per gli
“affari pauperili”
( cioè l’assistenza).
Sino
al secolo XIX ci furono conflitti elvetici anche aspri di competenza
tra consigli “politici”
e “patriziali”.
Queste assemblee discutevano sullo sfruttamento economico del terreno
(coltivazioni, rotazioni agronomiche, pascoli, boschi, caccia e
pesca) ed anche sull’ammissione od il rigetto dei forestieri
(tuttora in Svizzera la cittadinanza si acquisisce a livello
comunale, e non cantonale o federale): come avvenne, appunto, in alta
Valsesia, dove Dolcino, Margherita e Longino furono accolti, mentre
invece le truppe di repressione in rastrellamento degli eretici
furono respinte con forza.
La
sostituzione del Diritto tribale, poi longobardo, con il Diritto
Romano non fu certo “pacifica”
e la resistenza durò secoli. In molte valli gli uomini liberi
poterono conservare con le armi i loro “privilegi”,
cioè la loro
autonomia, le loro “regole”.
Le “vicìnie”
riuscirono a
sopravvivere sulle montagne, divenendo i cosiddetti “usi civici”
e si conservarono
sino all’inizio del XIX secolo. Per le alte valli di cui stiamo
parlando, possiamo rilevare che la tradizione culturale formatasi
durante l’Età finale del bronzo e del ferro, sta tramontando
soltanto con i nostri nonni, o addirittura con i nostri padri ( la
prima Guerra mondiale può
essere considerata lo jato ), come dimostra lo studio delle
tradizioni popolari, che hanno tramandato sino ad oggi antichissime
ritualità.
Oltre
alla “vicìnia”,
esiste un’altra
organizzazione comunitaria, la cui importanza è sfuggita agli
studiosi del Diritto italiano, in quanto nelle documentazioni
comunali se ne trovano soltanto labili tracce frammentarie: si tratta
di quelle che era chiamata (in Piemonte, ma non solo) la “Badìa “
o “Abbadìa”,
corporazione che, in origine, riuniva i giovani dal comune periodo di
“spupillamento”,
gelosa custode delle
ataviche libertà e della “cultura”
orale alternativa; lo
stesso nome di “Abbadìa”appare
come una sfida alla cultura ufficiale “scritta”,
quella codificata
nelle Abbazie del monachesimo medioevale.
Le
competenze stesse di queste corporazioni, ovvero l’organizzazione
della vita comunitaria, delle antiche regole, delle feste (quali i
carnevali ed i maggi), della difesa del territorio e dei suoi
confini, divengono quindi eredità vivente e ragione storica delle
insorgenze montanare e contadine, da quelle del “tuchinaggio”
antifeudale, alle
rivolte antifrancesi a cavallo tra XVIII e XIX secolo: tutte mirate a
ristabilire norme e valori infranti del passato (10).
Molte
“badìe” furono
cattolicizzate e divennero confraternite; i capi, gli “ abà”
si trasformarono in
“priori”
o addirittura santificati ( come Sant’Euseo di Serravalle Sesia).
Così, io sono convinto che Milano Sola, definito dalle fonti “ricco
contadino di Campertogno”,
che invita Dolcino in alta Valle, altri non è se non un “ abà”,
autorevole capo dei giovani della sua comunità, poiché non si
poteva essere “ricchi “ nell’agricoltura di sopravvivenza di
una comunità alpina agli inizi del XIV secolo; l’invito inoltre
non poteva essere “privato”
e prescindere da una volontà collettiva, appunto da una delibera
della “vicìnia”,
di dare ospitalità a decine di perseguitati.
La
comunità cristiana che Dolcino e Longino proponevano come
precorritrice del “Regno”,
è del tutto speculare, omologa a quella dei montanari, dove si
riscontrano i medesimi valori fondamentali: solidarietà e
fratellanza, comunione dei beni, rifiuto di ogni tipo di balzello
(taglie o decime che fossero), parità uomo/donna, nessun servo e
nessun padrone, ma Dio unico “Signore”,
rifiuto del denaro (si pensi al Segalello, fondatore del movimento
apostolico che “gettò via i denari”,
poichè l’economia
era fondata sul servizio comunitario e sul baratto…….)
Dolcino,
Longino e Margherita testimoniano, nel loro messaggio evangelico
radicale, la validità dell’ordinamento giuridico alpino,
rivitalizzato dai Longobardi e minacciato dal Diritto Romano che
sale dai centri urbani della pianura.
La
“crociata”,
invece, è la messa
in opera di uno strumento oppressivo per l’affermazione di principi
antitetici: gerarchia, privilegi riconosciuti ai signori feudali,
laici o ecclesiastici che siano; la donna considerata veicolo
diabolico; la moneta sonante, anziché il servizio solidale ed il
libero scambio.
La
sconfitta di Dolcino, Margherita e Longino segnerà l’inizio della
fine della civiltà alpina: alla luce del sole, rimarrà
l’ordinamento giuridico latino; ai “resistenti”
il buio dei boschi e
della notte, dove troveranno
rifugio i banditi; le
donne “vestali”
dell’antica cultura
agreste diventeranno “streghe”:
le fate giovani e belle saranno tramutate dalla cultura vincente in
vecchie malefiche megere. La pratica del libero scambio, in sfida
alla legge, sarà dei contrabbandieri.
Le
alte valli alpine presenteranno, nella loro decadenza economica,
politica e sociale, tutti i caratteri delle colonie, così come
avviene nel terzo mondo (11):
le materie prime prodotte ( si pensi ai metalli, cominciando
dall’oro, ma anche all’acqua, bene quanto mai prezioso), sono
consumate o trasformate nelle metropoli; le popolazioni sono
territorialmente divise con confini estranei alla loro realtà
economico-sociale; le Valli costituiscono una grande riserva
di mano d’opera (prima serve, poi operai ) e di buoni soldati; il
sistema viario di comunicazione da orizzontale, tra valle e valle,
sostituito da quello a raggiera che diparte dal centro metropolitano
per facilitare la pianurizzazione delle attività economiche; il
capitale sociale sparito, sostituito da quello dei metropolitani che
si impadroniscono della terra ( turismo speculativo che espelle gli
indigeni); la produzione agricola e artigianale soppiantata da quella
industriale metropolitana; gli indigeni considerati culturalmente
alienati, minus
habentes; gli idiomi
che esprimono la loro cultura bistrattata, degradati dal valore di
“lingua” a
“minus valore”
“ dialetto”, da
estirpare e buttare (la rapina del minus-valore !). Laddove i popoli
indigeni non concordano con i progetti elaborati dalle élites, che
mistificano il proprio tornaconto facendolo apparire come “progresso”
tout
court,
essi possono essere sempre rappresentati quali terroristi
pericolosi; primitivi, gretti, egoisti, ostacolo allo sviluppo.
E’
l’inversione dell’etica: colto, aperto e positivo il “cittadino”;
ignorante, rozzo, testardo e meritevole di “conversione”
di “emancipazione”,
quando non di severa
condanna, il “montanaro”
:insomma, un
“eretico”
, cui spettava, un
tempo, l’abitello giallo o il rogo, ed oggi il disprezzo sociale
dei benpensantismo cittadino.
E’
l’antica favola del lupo prepotente a monte e del povero agnello,
accusato di intorbidire l’acqua ma a valle…
Così
Dolcino, Margherita e Longino appaiono, emblematicamente, mitici eroi
di una civiltà alpina che “resiste”
. Personaggi maestosi
e tragici, in presa col destino e con le forze di una natura ostile,
eroi simili a quelli della tragedia greca che guardano il volto
misterioso del fato, cui non possono resistere; dovranno cedere,
saranno sbalzati fuori dalla vita ma, lottando, fedeli alla loro
passione,anche se soccombono, conservano una loro grande dignità.
Come
i personaggi del romanziere svizzero Charles-Ferdinand Ramuz
(1878-1947), ed in particolare penso al protagonista di un suo
romanzo celebre, Farinet,
montanaro reale, fuorilegge valdostano divenuto nel Canton Vallese un
mito (12).
Lo
scrittore friulano Carlo Sgorlon, in un suo romanzo racconta :
“la
moderna e sempre valida favola della prevaricazione dell’uomo sulla
natura, favola antica della dabbenaggine e del miraggio del progresso
che, alleati contro l’equilibrio della creazione, scatenano il
sangue ferito della terra. Perché uccidono il passato, scambiandolo
per passatismo, in nome di un avvenire che è furto, consacrazione,
improvvisa padronanza del fuoco degli dei”.
In
questo romanzo si staglia la figura di Siro, un montanaro contrario
alla strada ed alla diga progettata ed in fase di realizzo: il
racconto è ispirato alla tragedia del Vajont, anche se i toponimi
sono mutati.
“A
chi diceva, a Siro,: sei tu, fuori dal tempo. Dov’è il pericolo?
Nei lavori della strada? Replicava : ma certo. Cominciano sempre con
una strada. Se lasciate che la strada si faccia, poi sarà sempre
tardi per ogni cosa.”
Lui
conosceva le loro tecniche, le aveva viste applicate in molte altre
valli. Dopo la strada, vedeva gente che avrebbe messo le mani ingorde
su ogni cosa. Avrebbe sventrato i boschi per farne piste da sci,
costituito ogni possibile diavoleria: seggiovie, impianti di
risalita, funivie per salire in cima alle montagne senza muovere un
solo passo; avrebbe fabbricato alberghi, rovinato i nevai del
massiccio, e le valli e le montagne sarebbero state percorse da una
ragnatela di fili d’acciaio e di piloni di cemento. Avrebbero
deviato le acque……” “Le acque ? cosa centrano le acque? “ “
Non lo so. Dico per dire. So soltanto che rovinano tutto.” “
Siro, ragiona: la gente della valle aspetta da decenni che la strada
sia fatta”. Ma lui non voleva ragionare. Era sconvolto dalla sua
passione, e continuava a dire che bisognava fare una lega di tutta la
gente per bloccare il progetto che ci minacciava, correre in tutti i
paesi e soffiare con ogni forza dentro l’antico corno di bue, per
gettare allarme. Lo guardai negli occhi ed ebbi l’impressione che
non mi vedesse nemmeno. Mi sembra una sorta di eretico di altri
tempi, un frà Dolcino uscito da secoli remoti ed entrato chissà
come nel nostro tempo di motori e di macchine. Non si era accorto
che quell’epoca era finita, che il frate di Novara e la sua donna
dai capelli rossi erano stati bruciati vivi, e la sua gente
massacrata e dispersa. Si era perduto un grande sogno, quelle antiche
comunità montanare. Ma adesso i tempi erano cambiati, e sopravviveva
soltanto un suo pallido fantasma nel fatto che la gente affamata
andava a far legna nell’antico bosco demaniale. Tutto il resto era
cambiato. Oggi i grandi feudatari esistevano sotto forma di banche e
società finanziarie, le quali potevano anche riuscire in quello che
era stato impossibile ai vescovi medievali. L’avrebbero fatto anche
qui, ed anzi avevano già cominciato a farlo, ma opporsi era
un’illusione mitica e fuori dal tempo…….”(13).
Ramuz
e Sgorlon ci spiegano così, sia pure molto indirettamente, perché
il Movimento contro il “Treno alta velocità “ (la TAV) in valle
Susa abbia emblematicamente “recuperato”
frà Dolcino: è la seconda volta, dopo gli anni di fine –
principio secolo – quando il movimento operaio valsesiano e
biellese onorò il “precursore”
– che un movimento
popolare riscopre Dolcino e lo rivendica. In Valle Susa, e in
internet, circola una significativa lettera firmata “Dolcino e
Margherita, da nessun
luogo”
( Utopia) che è un inno alla libertà della montagna, una strenua
difesa di quella “bioregione”
che una colossale
strada ferrata vorrebbe ancor più sconvolgere (14).
Una
valle già percorsa da autostrada, superstrada e ferrovia,
sconquassata da una “grande opera”
che prevede montagne scavate per quindici anni, con milioni di
metri cubi di materiale pericoloso da trasportare da qualche parte;
cinquecento camions di transito giorno e notte nella valle per
trasportare i detriti scavati; tonnellate di polveri circolanti
nell’aria: le verifiche secondo le quali non ci sarebbe amianto nei
terreni si sono rivelate inattendibili, il movimento “No
TAV” ha portato
alla luce le lacune dal punto di vista scientifico e la Procura di
Torino ha aperto un’inchiesta. Si estende la desolazione di
panorami cementificati, la distruzione di prati, l’ombra di
viadotti, il grigio delle decine di piloni di cemento, antenne e
tralicci aumentati in modo esponenziale. Inoltre le falde deviate o
prosciugate, le acque inquinate. L’opera costa miliardi e miliardi
di euro è dunque certamente dannosa per l’impatto ambientale, ma
anche molto probabilmente inutile, come molti economisti hanno
evidenziato. Il movimento che ha riconosciuto in frà Dolcino un
emblema, antepone la tutela della bioregione e della salute agli
interessi di coloro che Sgorlon, nel suo romanzo, ha chiamato “i
nuovi feudatari”,
cioè poche ma potenti lobby economiche, spesso trasversali agli
schieramenti politici. In realtà si confonde il “progresso”,
che è liberazione
dal bisogno e dal servaggio, con lo sviluppo, che non deve essere
infinito, e che è destinato a schiantarsi a grande velocità contro
la barriera del limite ecologico. Si sostiene che la TAV è
indispensabile, altrimenti l’Italia non si modernizza.
Luciano
Gallino su la “Stampa”
(15)
si chiede se non
siano proprio gli abitanti della Val Susa a fare, invece, il vero
interesse nazionale, e che stiano spronandoci a pensare se è
davvero conveniente trasformare l’Italia nella piattaforma
logistica d’Europa, e se la perseveranza di realizzare la TAV senza
valide ragioni sia la conseguenza dell’incapacità di esplorare in
modo corretto altre opportunità di cui disponiamo.
Forse
questi frà Dolcino, Margherita e Longino strenui difensori della
bioregione alpina, e cioè di una regione-comunità in osmosi con il
territorio, sono trascendentali, più personaggi mitici, tramandatici
dalla tradizione popolare, che personalità storiche.
Da
Robin Hood sino a Ghino di Tacco, al “Passatore”
ed ai “banditi”
adottati dall’epica
popolare anche in tempi più recenti (16),
la leggenda sembra
consegnarci meglio dei documenti, una realtà più significante,
certamente più coinvolgente e affascinante.
André
Malraux (17)
lasciò scritto:
“solo il leggendario è vero”.
Prima di lui, Beaudelaire aveva esclamato : “Sei sicuro che la
leggenda sia proprio vera ? Ma che m’importa, se mi ha aiutato a
vivere !
“ E Alessandro
Dumas va ancora oltre : “Si può violare la storia, purchè ci
faccia un bel figliolo !”.
Dolcino,
Margherita e Longino furono torturati atrocemente ed arsi vivi il 1°
Giugno 1307. Malgrado secoli di demonizzazione, il movimento operaio
li riconobbe precursori della lotta per il riscatto degli oppressi, e
nel 1907 a Dolcino innalzò sul monte Massaro un obelisco alto
undici metri, abbattuto vent’anni dopo (1927) dal regime fascista.
Ancora
una volta si credeva di averla “ fatta finita”
con siffatti simboli scomodi. Il bisettimanale della curia, “Il
Biellese”,
scrisse allora che “quel povero cumulo di pietre aveva cessato di
essere, ciò che si augurò e si credette dai promotori, un faro ed
un punto di riferimento”(18).
Ma
non fu così. Nel 1974 sui ruderi di quell’obelisco sorse un cippo.
Oggi, Dolcino, Margherita e Longino ci rifanno sentire la loro voce
“altra”,
fuori dal coro, come eroi dell’autonomia e della salvaguardia delle
bioregioni.
Per
dirla con Giuseppe Giusti, “ dopo morti son più vivi di prima”.
Note
(1) Ex
seconda vero epistola eiusdem Dulcini,que facta fuit et missa anno
Domini MCCCIII in mense dicembri, excerpta sunt que secuntur. In
primis nominat se ipsum fratrem Dulcinum novariensen rectorem super
omnes dicte congregationis apostolice. Item, sororem Margaritam pre
ceteris sibi dilectissimam et fratrem Longinum de Pergamo et fratrem
Fredericum de Novaria et fratrem Albertum Carentinum et fratrem
Valdericum de Brixia discipulos; et ipsi et multi alii viri et
mulieres plus quam centus consimiles supradictis et alia multitudo
fratrum et sororum eiusdem congregationis in Italia plus quam IIII
milia, omnes invicem sine vinculo exterioris obedientie sed interiori
tantum subiecti et unitis. ( Bernardo Gui, De
secta illorum qui se
dicunt esse de ordine Apostolorum, in “
Raccolta degli storici italiani dal
cinquecento al millecinquecento, ordinata da L.M. Muratori”,
( Historia Fratris Dulcini Heresiarche,
a cura di Arnaldo Segarizzi). Tomo IX, parte V, Città di Castello,
1907, p. 22.
(2) Raniero
Orioli, Venit perfidus heresiarcha. Il
Movimento apostolico dolciniano dal 1260 al
1307, Istituto Storico
Italiano per il Medio Evo, Roma 1988, p 134.
Altra
bibliografia recente ed essenziale sull’argomento :
Elena
Rutelli, Fra Dolcino e gli Apostolici nella
storia e nella tradizione, prefazione di
Domenico Maselli, La Claudiana/Centro Studi Dolciniani, Torino 1979 ;
Corrado
Mornese e Gustavo Buratti ( a cura di), Frà
Dolcino egli Apostolici tra eresia, rivolta e roghi,
Centro Studi Dolciniani / DeriveApprodi, Roma 2000;
Corrado
Mornese , Eresia dolciniana e resistenza
montanara, DeriveApprodi Roma 2000;
Tavo Burat,
L’anarchia cristiana di fra Dolcino e
Margherita, Leone & Griffa, Biella 2002 e
2007.
(3) Acta
S. Offici Bonomie ab anno 1291 usque ad annum 1310 (A.S.O.)
a cura di L. Paolini (Vol. 1°) e R.
Orioli (Vol. II ) e di L. Paolini e R. Orioli (Vol. III), in Fonti
per la Storia d’Italia, 106, Roma 1982-1984, p. 408 e pp
395,487-490.
(4) Arnaldo
Segarizzi, Historia,etc.
cit.in L. Muratori,
cit.,p. XXXIII, n. 23.
(5) Cfr. G.
Biscaro, Eretici ed inquisitori lombardi
(1299-1318) in
R. Deputazione sovra gli studi di Storia patria per le antiche
province e in Lombardia, Miscellanea si Storia Italiana, Serie III,
19 (1922) pp. 525-526, passim per Lanfranco.
La
sopravvivenza dolciniana nella bergamasca dopo i roghi, (a Biella ed
a Vercelli) di Dolcino,Margherita e Longino, sarà rilevata a
Gandino, Albino, Longuello e Martinengo, dove si è avuta la
“sovrapposizione della dottrina dolciniana alla vecchie credenze
dei poveri lombardi (valdesi) e a quelle più vecchie dei catari, già
dominanti nel territorio di Bergamo ( e si ritiene che questa
continuità) si fosse vieppiù intensificata negli anni successivi,
procurando alla setta rinnovellata maggiore vigoria di fede e di
sentimenti, nuovi e numerosi proseliti”
(G. Biscaro,
cit. p.
500). All’Orioli sembra tuttavia che “più che a nuovi adepti,per
il Bergamasco,sia il caso di pensare a sopravvivenze di vecchio
proselitismo, formatosi, con ogni probabilità, intorno al 1303-1304,
durante il passaggio ed il soggiorno dei Dolciniani nella
zona “. (Orioli,
cit.p. 291). Nel 1317, l’inquisitore Giovanni da Fontana opera un
repulisti antiereticale nel Bergamasco che si conclude con diciotto
arresti e dodici roghi (Biscaro, cit.pp.
498-500, 555-556)
(6) R.
Orioli, cit. pp.
227-229
(7) R.
Orioli, cit. pp 320
(8)……..ductis
secum dicto Milano Sola et aliis multis personis de dicto loco
Campartolii et aliis locis circumstantibus cum omnibus eorum
bonis,quas personas ipse Dulcinus traxerat ad falsam sectam, se
reduxerunt ad quondam montes diocesis Novarie, ubi dicitur ad
Balmam….(Historia, etc. cit. p.4).
(9) Dictus
frater Dulcinus heresiarcha personaliter captus fuit super montibus
Triverii una cum Margherita de Tridento eius socia, et Longinus de
Bergamo,qui erat de Cataneis da Faedo vel de Sacco, et erant maiores
in dicta secta ( Historia, etc. cit. p.11)
Predictus
Dolcinum, Longinum et Margaritam de Tridento tradidit sudicio
seculari,ita quod dicta Margarita primo fuit combusta super quidam
columna alta posita in arena Servi et plantata ibi et ordinata,ut
omnibus videri possent positisque in eorum conspectum vasibus ignem
plenis ordinatus ad calefaciendum tenabulas ad carburendum carnes
ipsorum, adhibitis carnifibius, qui cum tenabulis ferri candentis
carnes eorum laniabant et frustatim gravior esset; multi quos
leserant in personis et here videntes tantam stragem talemque
iustitiam fieri de eisdem consolationem habueunt et gaudium de
vindicta penaque eorum, ut aliis transiret in exemplum : bonis in
laetitiam, malis vero ad supplicium et totius secte predicte pavorem
detrimentum et obbrobrium sempiternum. Predicte autem pene illate
fuerunt predictis Dulcino et Longino in locis diversis, videlicet
Dulcinus in civitate Vercellarum, ipsum ducendo cum cruciatibus et
tormentis suprascriptis per via set vicos ac palesa dicte civitatis,
Longinus vere in loco Bugelle
……..(Historia,
etc. cit. p. 12).
Non abbiamo
un’iconografia affidabile dei capi apostolici, ma soltanto ritratti
di fantasia privi di valore storico, “ come la teatrale gestualità
iconografica del dipinto del 1880 approntato nella chiesa matrice di
Trivero ( Biella) e raffigurante un Dolcino in talare bianca e
cappello piumato secentesco, una Margherita che ricorda Francesca da
Rimini di Ingres ed un Longino in armatura secentesca “ (R. Orioli,
Venit ecc. cit. p 205
n. 282).
(10) Cfr.
Gualtiero Cìola, Le rivolte contadine in
Europa,in G. Cìolan, A. Colla, C. Mutti, T.
Mudry, Rivolte e guerre contadine ,
Soc. ed. Barbarossa, Milano,p.19.
Sulle
“Badìe” o
“Abbazie dei Folli”:
G.C. Pola Falletti Villafalletto, Associazioni
Giovanili e Feste
Antiche ,
vol 1°, Torino 1939.
(11)
Cfr.Gustavo Buratti, Decolonizzare le Alpi
, in AA.VV. Prospettive
di vita nell’arco alpino. Interventi di uomini di studio e
d’esperienza sul passato,il presente e il futuro di vita nell’arco
alpino
, Jaca Book, Milano 1982, pp. 64-83.
(12) Corrado
Mornese, Farinet il falsario dal grande cuore
, in C. Mornese e G. Buratti(a cura di),
Banditi e
ribelli dimenticati , Lampi di Stampa, Milano
2006,pp. 131-134 e 338-343.
(13) Carlo
Sgorlon, L’ultima valle,
Oscar Mondatori, Milano 1989, pp 53-55.
(14) Cfr.
Vittorio Agnoletto, Quei ripensamenti sulla
TAV, lettera al “Corriere
della Sera”,12.X.2006,p. 53; Alleanza per
l’opposizione a tutte le nocività, Treni ad
alta velocità. Perché
il treno ad alta velocità è un danno individuale e un flagello
collettivo ;
Nautilus, Torino 1993 e 1996; Antonio G. Calafati, Dove
sono le ragioni del si ? La TAV in Val Susa
nella società della conoscenza,
Seb 27, Torino 2006.
(15) “La
Stampa”,7.12.2005
(16) C.
Mornese e G. Buratti, ( a cura di), cit.
(17) André
Malraux ( 1901-1976), scrittore e uomo politico francese,archeologo,
studioso di Sanscrito,personalità della Resistenza e dell’impegno
anticolonialista ,combattente della guerra di Spagna, ex internato.
Nei suoi
romanzi primeggia l’aventure, l’azione
sollecitata da una volontà imperiosa, dove l’eroe ritrova la
coscienza della solidarietà umana.
I suoi
numerosi romanzi ( 1921-1949) sono raccolti in un volume unico,La
voix du silence (1951).
(18)
L’obelisco di frà Dolcino abbattuto,
“Il Biellese” –
bisettimanale cattolico, 2 agosto 1927.
Il
movimento operaio, a partire dalla seconda metà del XIX secolo,
riscoprirà e "rivendicherà" Dolcino, riconoscendo in lui
il precursore delle lotte di liberazione delle classi subalterne, e
soprattutto l'apostolo del "Cristo socialista", vittima del
potere politico, economico e colonialista. Nel 1907, VI° centenario
del Martirio, sul monte Massaro (da "Mazzaro", altro
toponimo relativo al massacro… ) è eretto dagli operai un obelisco
alto 11 metri, inaugurato l’11 agosto alla presenza di 10.000
convenuti entusiasti che coprono la montagna di bandiere rosse.
Vent'anni dopo, a fine luglio 1927 (erano gli anni del fidanzamento
del regime fascista con la Chiesa cattolica: nel 1929 ci sarà il
matrimonio/concordato) il fascismo abbatterà quel monumento punto di
riferimento per una riscossa della cultura "altra". Il 14
settembre 1974, 600 anni dopo l'ultima condanna degli Apostolici
(sinodo di Narbona), sui ruderi dell'obelisco fiorisce un cippo; del
Comitato promotore fanno parte, tra gli altri, Cino Moscatelli, epico
comandante della Resistenza partigiana "nei luoghi dove combatté
Dolcino", Dario Fo, Franca Rame e Osvaldo Coissono, uno dei sei
redattori di quella "dichiarazione di Chivasso” ( 13 dicembre
1943) con la quale si preconizza, per la nuova Italia, il
federalismo, l’autonomia politica, culturale e amministrativa delle
Valli alpine. Ogni anno, al Massaro (panoramica Zegna, Trivero,
Biella) si celebra una festa libertaria, la seconda domenica di
settembre.
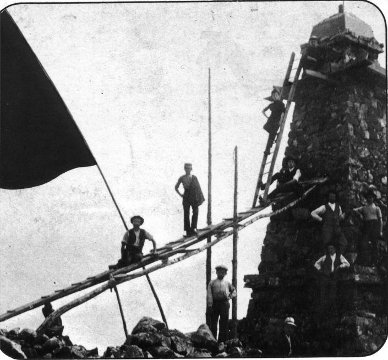
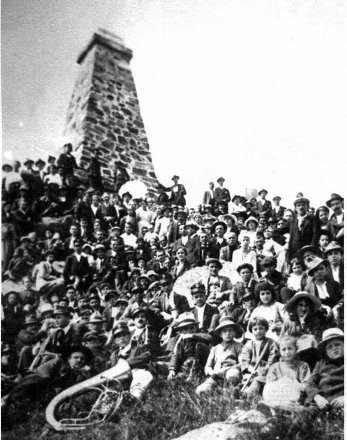
Qui di seguito due
stralci della stampa socialista biellese del 1907
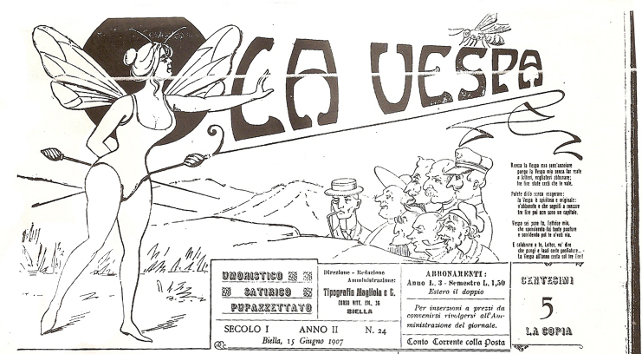
LA VESPA
15 giugno 1907
PER IL VI° CENTENARIO del
SUPPLIZIO DI FRA DOLCINO
Quale improvviso faro in
notte oscura
Adduce in porto pavido
nocchiero,
tale, in quel servo secol
di paura,
brillò il tuo rogo per
l’uman pensiero.
Dal tuo cener, disperso
alla planura
Da’ venti, battaglier
surse Lutero;
e risonò più libera e
sicura
la tua voce nel riso di
Voltero.
A l’alba santa de
l’ottantanove
Il tuo ribelle spirito
ridesto
Parigi armò di ferro e di
furore.
E or, col verbo di Marx,
gridi a le nove
Plebi frementi: In alto i
cori! Presto
verrà il dì del riscatto
e dell’amore.
Giuseppe Giorgio Mossa
IL CORRIERE
BIELLESE
18 agosto
1907
Sul Monte dei Ribelli
Giove
Pluvio – dopo tanto tempo di inattività – proprio sabato –
alla vigilia della commemorazione di Fra Dolcino – ha voluto
mostrare il suo malumore. Quasi durante tutta la giornata di sabato
la pioggia è caduta a catinelle. E neppure verso sera, il tempo ha
mostrato di volersi rasserenare.
Ci
siamo cacciati in letto disperati . Contro il tempo non ci si può
nulla. Il tempo fa i comodacci propri e quando vuol inzupparci i
panni, non ci domanda punto il “permesso”.
Contro
il tempo è forse essere filosofi, e se piove…. Lasciar piovere, e
se fa sole lasciarsi scottare il groppone.
Ma
pure non potevamo neppur pensare che – causa cattivo tempo – la
commemorazione dovesse essere rimandata. Il rinvio – in questi
casi - vuol dire sempre rovina della festa, poiché ammorza due
terzi dell’entusiasmo e diminuisce di molto il numero dei
partecipanti. E la non riuscita diventava una mortificazione ed un
avvilimento per tutti i buoni che da ogni paese, anche
lontanissimo, hanno versato il loro obolo, e per tutti gli altri
valorosi che hanno lavorato gratuitamente di spalla e di braccia per
innalzare l’obelisco. La non riuscita avrebbe anche ridotta a zero
l’importanza della festa e avrebbe anche ridotta a zero
l’importanza della festa e avrebbe fatto sghignazzare i nostri
avversari.
Per
tutte queste ragioni, domenica mattina abbiamo sporto il naso fuor
dalla finestra con mente tutta piena di punti interrogativi.
Pioverà? Verrà gente? Riuscirà?
Abbiamo
visto in cielo scintillare le stelle e l’animo s’è riempito di
speranza. In strada abbiamo incontrato gruppi numerosi anche essi
avviati verso la stazione. E ci siamo convinti subito che la festa
non poteva fallire.
La partenza
da Biella
La
augusta ed…. economica stazione delle Ferrovie Economiche è presa
d’assalto. Siamo in molti. Troviamo molti compagni e i amici che
vengono dai paesi vicini e anche lontani. Molti sono venuti col
cavallo di S. Francesco. Ma non sono stanchi: Chiacchierano, ridono,
salutano. Non mancano le donne. Brave!
I
vagoni sono zeppi. Il treno lunghissimo, si mette in moto con la
movenza di un bestione sonnolento.
Lungo il
percorso
Dal
reclusorio industriale dei Rivetti – vicino al quale il treno
passa – molti ci gridano in silenzio. Noi gridiamo: Viva Fra
Dolcino!.
Vorremmo
gridare loro dappiù. Poiché essi dormono e subiscono in pace il
lavoro enorme vorremmo loro gridare: Venite, venite anche voi!
Ma
il treno affretta la corsa. Siamo a Chiavazza, e poi a Vigliano. E
ad ognuna delle fermate la gente sale numerosa affollatissima.
Valdengo,
Ceretto, Quaregna. Ecco tre paesi dai quali non salirà alcuno.
Invece, no. Anche qui troviamo gente che ci aspetta e sale con noi.
A
Cossato, Lessona, Strona, delle vere folle invadono i vagoni.
Troviamo molti curiosi che vengono a guardarci ovunque il nostro
treno passa fischiettando e sbuffando. Noi siamo tutti ai
finestrini. Viva Fra Dolcino! Gridiamo. Viva Fra Dolcino! Ci si
risponde.
E
noi pensiamo con tristezza: forse, di questi uomini che ci seguono
con lo sguardo e di queste donne che ci salutano sorridenti, molti e
molte hanno la nostra stessa fede e verrebbero con noi. Ci
chiediamo: Perché non vengono?
Rispondiamo
noi stessi. Lo sappiamo, lo sapete, lo sanno tutti. In mezzo ai
miserabili senza soldi ve ne sono di più miserabili sempre, che non
vedono la croce di un quattrino, che sono condannati eternamente a
piegare la schiena.
Da
lontano spunta, librandosi nel cielo, l’obelisco. Noi lo guardiamo
e lo salutiamo plaudenti.
A
Vallemosso
Siamo
arrivati alla prima tappa. La musica ci saluta con una marcia piena
di brio.
La
folla grida e batte le mani entusiasta.
Incominciamo
a sventolare le bandiere.
Il
corteo è in breve disciplinato e si avvia festosamente verso Mosso
S. Maria.
A Mosso S.
Maria
Da
tutte le parti viene gente ad incontrarci. Un'altra musica viene
verso di noi. Così al suono dei nostri inni, invadiamo la piazza.
E’ ancora presto. Si ingoia un boccone e poi molti si incamminano
verso il monte.
Verso
la vetta.
Mentre
saliamo faticosamente, guardiamo l’obelisco che si vede benissimo.
La sua vista ci allieta. E si cammina, si cammina: tutto il pendio
formicola di gente che si arrampica, che suda, che riposa. Più in
altro, altra gente cerca di arrivare fin in vetta.
Si
va senza fretta. Per ingannare il tempo e la fatica, si chiacchiera.
I preti (prega per noi, don Maccalli!) entrano in tutti i discorsi.
Tutti
sono lieti che sia stata organizzata questa grandiosa dimostrazione
anticlericale.
Era
ora di svegliarci, di far vedere che non siamo degli imbecilli, di
dimostrare che siamo liberi e coscienti! Anche le donne sono con
noi.
La
salita è difficile. Ci si stanca. Ma ci incoraggiamo con un motto,
con la mano, con la voce. E si riprende il cammino.
Sul monte
Ribelle
Siamo
alla meta.
Tutto
il dorso del monte rigurgita di uomini, di donne, di ragazzi, venuti
da ogni dove.
Intorno
all’obelisco si è accampata una vera calca di gente che mangia,
scherza, beve, attendono l’ora dei discorsi.
Tratto,
tratto echeggiano evviva ed applausi.
Poi
arriva il corteo. Sul
vertice dell’obelisco vien piantata la rossa bandiera che sventola
agitata dal vento ed inondata di sole.
Si
avvicina l’ora dei discorsi. Giudo Podrecca col piccolo Goliardo
fra le braccia, seguito dalla famiglia e da molti compagni, sale
verso l’obelisco. Ovunque passa è salutato da applausi e da
evviva entusiastici. Le musiche suonano.
Il comizio
Sono
appena le 13. Il sole dardeggia terribilmente, ma pure intorno
all’obelisco la folla che vi si accalca è enorme –
incalcolabile. Saranno otto o diecimila persone.
Il
calcolo esatto non è possibile. Dinnanzi a noi vediamo un mare
sterminato teste, confuse insieme. Verso le 13, il prof. Corte, per
il Comitato, dichiara aperto il comizio e l’avv.
Umberto
Savio legge l’elenco delle società intervenute.
Società con bandiera:
Candelo,
Società operaia
Occhieppo
inferiore, Leghe riunite
Biella,
Società Archimede
Id.
Camera del Lavoro
Id,
Sezione socialista
Id,
Circolo socialista
Brusnengo,
Società agricoltori ed operai
Vigliano,
Società mutuo soccorso
Valle
Mosso, circolo socialista
Biella,
unione pannilana
Biella,
Federazione metallurgica
Vercelli,
Associazione generale operai
Id,
Camera del Lavoro
Id,
Società Archimede
Flecchia,
società mutuo soccorso
Pienceri,
circolo socialista
Flecchia,
circolo socialista
Veglio
Mosso, società mutua figli del lavoro
MANCANTE
Coggiola,
circolo socialista
Masserano,
circolo socialista
Graglia-Muzzano,
circolo socialista
Biella,
sezione libero pensiero
Camandona,
società mutuo soccorso
Ronco,
sezione socialista
Adorno,
municipio
Id,
società operaia
Id,
circolo socialista
Sagliano
Micca, società operaia
Id,
società cappellai
Valle
S. Nicolao, sezione socialista
Pollone,
circolo socialista
Cossato,
sezione socialista
Id,
società operai
Id,
municipio
Valle
S. Nicolao, società operai
Lesiona,
lega contadini
Soprana,
società operaia
Croce
Mosso, municipio
Borgosesia,
federazione lavoranti panettieri
Aranco,
circolo vinicolo
Serravalle,
lega cartai
Id,
sezione socialista
Biella,
sezione ferrovieri
Castelletto
Cervo, sezione socialista
Strona,
municipio
Trivero,
società operaia
Croce
Mosso, sezione socialista
Id,
società operaia tessitori
Torino,
loggia massonica “Dante Alighieri”
Alessandria
loggia massonica “Vochieri”
Milano,
loggia massonica “La ragione”
Mezzana,
municipio
Valle
Strona e Ponzone, lega arti tessili
Trivero,
sezione socialista
Chiavazza,
sezione socialista
Adorno,
società cappellai
Biella,
loggia massonica “verità”
Torino,
loggia massonica “Cavour”
Id,
loggia massonica “Ausonia”
Pinerolo,
loggia massonica “G. Bruno”
Asti,
loggia massonica “V. Alfieri”
Bergamo,
loggia massonica “Pontida”
Genova,
loggia massonica “Stella d’Italia”
Valle
mosso, antica società operaia
Mezzana,
circolo anticlericale
Id,
circolo Mameli
Varallo,
lega muratori
Id,
circolo socialista
Adorno,
unione miglioramento cotonieri
Prato
Sesia, sezione socialista
Id,
società operaia
Biella,
unione cooperativa
Roma,
Grande oriente, grande loggia simbolica
Piane
Sesia, sezione socialista
Intervennero
senza bandiera:
Portula,
sezione socialista
Candelo,
circolo socialista
Veglio
Mosso, municipio
Pralungo
(S. Eurosia), circolo socialista
Vercelli,
circolo socialista
Id,
società muratori e affini
Masserano,
lega contadini
Vercelli,
lega metallurgici
Id,
lega orefici
Id,
lega facchini e carrettieri
Id,
lega calzolai
Id,
lega falegnami
Ronco,
lega arte edilizia
Valle
S. Nicolao, gruppo femminile
Pollone,
sezione pann.
Sordevolo,
sezione socialista
Lesiona,
sezione socialista
Vergnasco,
cooperativa
Id,
società operaia
Alessandria,
municipio
Soprana,
circolo socialista
Id,
municipio
Tavigliano,
lavoranti cappellai
Zumaglia,
municipio
Id,
società mutuo soccorso
26.
Id, sezione socialista
La
raccolta degli articoli sulla stampa Biellese è stata pubblicata
nel libro Maledetto
Fra dolcino – Storia di una memoria scandalosa.
a cura di C.
Mornese e Tavo Burat - ed. Lampi di stampa. 2007.
APPENDICE
Articoli
di Paolo Secco pubblicati su OUSITANIO VIVO sul tema delle Eresie
nel Cuneese.
DALMAZZO
E LA LEGIONE TEBEA
O.V.
n. 3, Marzo 2000 di
Paolo Secco
Inizia
con questo numero una nuova rubrica che percorrerà la storia nel
corso dei secoli della cultura religiosa nelle valli Occitane, con
riferimenti, quando sarà il caso, alle zone limitrofe, cercando di
cogliere il significato, al di là delle fonti storiche ufficiali e
delle interpretazioni pseudo oggettive dei fatti, di tale
religiosità, permeata talvolta da tradizioni e culti di matrice non
strettamente ortodossa, tramandatisi fino ai giorni nostri. Si
cercherà insomma di fare una panoramica storica generale di come il
cristianesimo, nel corso del tempo, abbia condizionato, se non
addirittura plasmato la cultura occitana alpina che, pur con le sue
peculiarità, non è mai stata cosa a sè in relazione all’area
Occitana presente fino ai Pirenei. Per fare tutto ciò è necessaria
peraltro la collaborazione di tutti coloro che, interessati
all’argomento, abbiano voglia e tempo di portare a conoscenza di
altri fatti, notizie, ricordi tramandatisi magari nell’ambito
famigliare, riguardanti l’oggetto della nostra ricerca, così da
creare una sorta di archivio, e qui il nostro obbiettivo si fa
sicuramente immodesto ma estremamente interessante. Tutto ciò in
quanto nello studio delle culture tradizionali si presenta sovente
il fatto che alcune persone conoscono avvenimenti, particolari modi
di dire o accadimenti vari da sempre presenti nella trasmissione
orale tra generazioni, di cui non si ha però la consapevolezza
dell’eventuale valore storico-documentale. Si parlerà anche dei
movimenti ereticali, presenti in modo assai diffuso nell’Occitania
Sud Occidentale (Catari) e in alcune zone del nord Italia
(Valdesi-Catari), ma con influssi senza dubbio importanti, anche se
circoscritti geograficamente, nelle nostre vallate.
La storia dell’evangelizzazione è ovunque caratterizzata da una
serie notevole di tradizioni ove leggenda e realtà finiscono per
confondersi, rendendo il più delle volte difficile comprendere
quanto di vero sia accaduto. E’ certa comunque, o almeno da quasi
tutti gli storici accettata, la presenza nelle nostre valli
Vermenagna, Gesso e Stura, nella prima parte del III secolo d.C.di
tal Dalmazzo, quello che sarà presto da tutti assunto al ruolo di
santo.. Non mancava allora nei nostri paesi qualche sporadica
presenza cristiana, se non altro per il frequente avvicendarsi di
funzionari imperiali e militari romani già evangelizzati, e per i
continui contatti commerciali con la Gallia Transalpina, ove già
esistevano forti nuclei cristiani, in particolare a Nizza e Lione.
Tuttavia predominava pressochè incontrastata una cultura di stampo
pagano, pur in forme non ben definite e sicuramente varie. La
tradizione cristiano-popolare nei secoli successivi presenta la
figura del santo secondo uno schema tipico dell’agiografia
medioevale. Dalmazzo, di nobili origini romane, apparteneva infatti
alla famiglia Flavia Secunda, e si era proposto il compito di
cristianizzare i popoli pagani, dopo aver ovviamente abbandonato
tutti i beni di famiglia. Alcuni storici, in contrapposizione
(Gabotto), lo identificano in un predicatore venuto non si sa bene
come e perchè da lontane terre straniere. Più probabilmente, come
alcuni studi recenti denotano, era di origine locale; ma qualunque
sia stata la sua provenienza, è entrato prepotentemente nella
tradizione popolare successiva come un santo taumaturgo di
eccezionali capacità. Si tramandano infatti sue guarigioni
miracolose ad Alba, a Milano e fino in Provenza. E fu proprio al
ritorno da uno dei suoi viaggi al servizio del Vangelo che trovò la
morte, si dice, il 5 dicembre 254 d.C. alla confluenza dei fiumi
Gesso e Vermenagna presso il nucleo abitativo di Pedona (1)
attuale Borgo San Dalmazzo, assalito, non si sa bene da chi, con
alcuni suoi compagni e con alcuni abitanti del luogo giunti ad
accoglierlo. Come abbiamo detto, le fonti agiografiche fanno di
Dalmazzo un martire del III° secolo, ucciso appunto ai tempi
dell’Imperatore Gallieno e di Papa Cornelio, ma tutto ciò
richiederebbe uno studio molto approfondito e soprattutto critico,
in quanto in realtà non esistono testimonianze dirette dell’epoca
in questione. La fonte più antica in proposito, ma anch’essa
comunque discutibile, è un’omelia “In dedicatione Ecclesiae”,
attribuita al vescovo di Cimiez Valeriano, negli anni 450-460. Testo
in cui, riferendosi al valore umano e religioso del martirio, si
accenna appunto ad un martire divenuto tale nel luogo ove “due
rivi limpidissimi mescolano le loro acque”. (2)
Per riprendere peraltro il discorso su quanto è stato trasmesso nei
secoli dalla memoria popolare, alcuni santi, quali Magno, Costanzo,
Besso, che la tradizione identifica appunto come appartenenti alla
famosa Legione Tebea, sono stati invece, da alcuni studi recenti,
riportati nell’ambito di una più probabile influenza Dalmaziana,
come suoi eventuali discepoli nel periodo successivo al martirio. Si
inserisce a questo punto un discorso complesso su quello che fu
effettivamente l’influsso e l’importanza della cosi detta
“Decima Legio” la famosa Legione Tebea appena citata. Denominata
in molti modi (Angelica Legio, Beata Legio) viene nominata, ad
esempio, nel 434 dal Vescovo di Lione Eucherio nella “Passio
Acaunensium Martyrum” (3).
La tradizione riporta di un contingente di Legionari Romani
reclutati “in natione thebea” (Egitto), inviati nel 286 da
Diocleziano nei pressi di Martigny (Octodurium), in aiuto delle
truppe già presenti sul luogo, impegnate contro le popolazioni
locali. La legione sembra si sia rifiutata, in quanto composta
completamente dai soldati cristiani, di massacrare popolazioni
inermi, e fu così passata per le armi. In questa versione, che è
forse la più attendibile, è verosimile pensare, tenuto conto della
consistenza numerica della legione, ad una decimazione, il che
spiegherebbe e renderebbe logica la sopravvivenza di molti che in
seguito, disertando, si rifugiarono nelle regioni più remote
dell’arco alpino, facendo così opera di evangelizzazione. Si
ricordano almeno 400 nomi di soldati della legione scampati
all’esecuzione di “Agaunum”, diventati successivamente oggetto
di culto e ovviamente santificati; di questi almeno una cinquantina
in Piemonte e altri ancora in Francia, Svizzera, Germania.
Ovviamente l’elenco è incompleto e comunque non sempre
attendibile, sta di fatto che le figure di questi santi, passati
nella tradizione popolare come protettori di paesi, guaritori,
guerrieri, praticamente sempre martiri, compaiono quasi ovunque
rappresentati in divisa da legionari nell’iconografia locale
(cappelle, quadri, affreschi). E’ anche significativo il fatto che
tutti questi valorosi, scampati ad una condanna ingiusta, siano
rimasti poi vittime delle popolazioni locali, o almeno di una parte
di esse, come reazione alla pretesa di evangelizzazione, che avrebbe
comportato l’abbandono di antichi culti e tradizioni insiti nella
cultura del tempo. ^
(1) - L’allora Pedona era sicuramente uno dei maggiori centri
abitativi del Sud Piemonte. Assunta a Municipium. già nel I°
secolo d.C. era sede di una “statio doganale” per il controllo
del traffico attraverso i valichi delle Alpi Marittime, con
l’imposizione di un dazio pari al 2,5% del valore delle merci in
transito (Quadragesima Galliarum)
^
(2) - “Storia religiosa delle Valli Cuneesi - Diocesi di Cuneo”
a cura della Curia Vescovile, Cuneo.
^
(3) - “San Dalmazzo di Pedona” C. Tosco -SSSAA di Cuneo, 1996.
“Le vie della fede attraverso le Alpi” C.Bocca - M. Centini,
Ivrea, 1994.
LA
COMPARSA DELL’ERESIA NELL’EUROPA CRISTIANA
O.V.
n. 8, Settembre 2000
di Paolo Secco
Dopo
i secoli in cui le invasioni saraceno/ungare furono al centro della
vita quotidiana delle nostre genti, quando la dottrina cristiana,
nel pieno del suo sviluppo, aveva ormai conquistato tutta l’Europa,
arriviamo finalmente ad un periodo di relativa stabilità ed
equilibrio socio-religioso.
Dopo
le grandi paure, figlie delle terrificanti profezie apocalittiche
che indicavano la fine del millennio come sicura fine del mondo,
all’alba del nuovo millennio, come un brutto sogno, comincia a
delinearsi nella mentalità dei credenti una nuova visione della
vita cristiana.
All’inizio
del X° secolo, per opera di Guglielmo I°, duca di Aquitania, e
dell’Abate Bernone, era stata fondata in Francia l’Abbazia di
Cluny, la più famosa ed importante nei secoli a venire.
In
poco tempo, superando i princìpi e gli stimoli del monachesimo
originario (il lavoro, la preghiera, l’isolamento dal mondo) Cluny
divenne un centro di potere enorme, ago della bilancia nelle scelte
politiche di tutta l’Europa occidentale, accumulò ingenti
ricchezze, esautorando addirittura il papato in molte situazioni di
intervento nell’ambito religioso-culturale.(1)
In
questo periodo è veramente difficile distinguere storia religiosa e
storia istituzionale, il concetto di Chiesa viene fatto coincidere
con il suo vertice, ed il papato cerca di riservarsi ogni
rappresentanza del divino in terra. In Occidente risulta infatti
decisiva la riforma gregoriana, operata appunto da Gregorio VII°
nel periodo del suo pontificato, tra il 1073 e il 1085. (2)
Nella lotta contro il potere costituito, per l’affermarsi
della "libertas ecclesiae", la libertà e indipendenza
della Chiesa dai poteri laici, le autorità ecclesiastiche
rivendicano il diritto di intromettersi in qualsiasi aspetto della
vita quotidiana, rendendosi così giudici di ogni comportamento dei
fedeli, dalle loro vicende più intime fino agli avvenimenti più
importanti. E’ questo un processo che porterà a pesanti conflitti
con i poteri forti, e a livello più quotidiano, con gli interessi
laici e materiali di quelle classi emergenti di mercanti, artigiani,
e più in generale di "cittadini", che a poco a poco dal
XII° secolo verranno a formarsi. (3)
Contemporaneamente,
mentre il vertice ecclesiastico è impegnato ad irrobustirsi, alla
periferia della cattolicità nascono nuovi movimenti monastici: i
Vallombrosiani e i Camaldolesi in Italia, i Certosini e i
Cistercensi in Francia, comunità che daranno spunto a tutta la
spiritualità dei secoli a venire.
Fra
le stesse popolazioni sorgono fermenti di critica dovuti in buona
parte alla corruzione del clero, evidenziata agli occhi di tutti con
casi di simonia, concubinaggio e malaffare. Nascono così idee di
riforma che, se da un lato daranno luogo ai noti esempi di vita
apostolica basati sulla povertà, citiamo per brevità San
Francesco, gli Ordini di Frati Minori, gli Ordini Mendicanti,
d’altro canto sfoceranno in una serie ininterrotta di movimenti
eterodossi, che spesso verranno impropriamente chiamati Ereticali.
Il
vocabolo greco "hàiresis" significava semplicemente
"scelta". Fu Paolo di Tarso, il futuro San Paolo, nella
Prima Lettera ai Corinzi, attorno al 50 d.c., ad usare questa parola
in senso negativo, riferendosi a chi aveva fatto una scelta
dogmatica differente. Costituitasi poi la Chiesa come istituzione
gerarchica, depositaria del "Patrimonium Fidei" (4),
l’eresia si configura come elemento disgregativo dell’unità
religiosa, per cui prevale il concetto che gli eretici non devono
soltanto essere confutati ed evitati, ma puniti come traditori.
Eresie
furono da sempre presenti, fin dai primi secoli dell’era
cristiana (Gnostici, Pauliciani, Docetisti) ma in maggioranza si
trattava di confutazioni e diversificazioni di stampo prettamente
teologico – dottrinale, non toccando peraltro la gran massa dei
fedeli. Il più delle volte tali sistemi di pensiero si persero nel
tempo, soffocati dall’espandersi e dall’intransigenza
dell’ortodossia ufficiale, altre volte furono soffocati nel
sangue, come nel caso noto di Priscilliano, Vescovo di Avila, in
Spagna, giustiziato nel 385. Fu questo probabilmente il primo caso
di condanna a morte di eretici. Priscilliano, che in realtà
promuoveva un genere di vita ascetico ed intransigente, con aspetti
dottrinali non troppo evidenti di dualismo, subì per primo quella
che secoli più avanti divenne una regola nei processi
inquisitoriali, la commistione fra eresia e magia (5)
Ma per ritornare al periodo in questione, il cronista Ademaro di
Chabannes ci informa della comparsa nel 1018, in Aquitania, di
gruppi di Manichei, ovvero eretici che, a suo parere, ripercorrevano
le dottrine di Mani, importante figura del III° secolo, fondatore
di una religione dualista (6).
Costoro seducevano le folle, negando, tra l’altro, il battesimo,
gli altri sacramenti e tutto quanto proprio del corrente
insegnamento cristiano (7).
Alcuni anni dopo, nel 1022, Ademaro ancora una volta designa
come Manichei, e quindi eretici, un gruppo di canonici di Orlèans.
L’episodio è sicuramente uno dei più noti, ne parla infatti
diffusamente anche Raoul Glaber, monaco borgognone, autore dei
"Cinque libri di Storia, 900-1044", considerato tra i
maggiori cronisti dell’epoca. Il movimento in questione non
risultò per la verità molto esteso, e fu presto evidente che
coinvolgeva soltanto una ristretta cerchia di uomini di cultura
nell’ambito della chiesa locale; furono condotti, in numero di
sedici, dinnanzi ad un Concilio, giudicati colpevoli di eresia e
quasi tutti bruciati sul rogo. In questo caso fu poi chiaro, da
fonti successive, come la differenza culturale fra i canonici ed i
loro giudici non permise a questi ultimi di cogliere appieno le
sfumature concettuali e l’eterodossia del gruppo, tanto da usare
genericamente il termine di Manichei. Negli stessi anni è
documentata, se così si può dire, una vicenda a noi molto più
vicina, sia per localizzazione geografica – si svolse infatti
nelle Langhe – sia per motivi attinenti alla storia successiva
dell’eresia Catara o Albigese: ci riferiamo infatti ai cosiddetti
Catari di Monforte.
Note:
Cantarella G.Maria, "I monaci di Cluny" Ed.
Einaudi, 1993-1997.
"Manuale
di storia delle religioni" a cura di Filoramo, Massenzio,
Raveri, Scarpi. Ed. La terza, 1998.
Grado
G. Merlo, "Il cristianesimo latino bassomedioevale" (in
"Storia del Cristianesimo-Il Medioevo" a cura di Filoramo
e Menozzi, Ed. Laterza, 1997.)
Craveri
Marcello, "L’Eresia, dagli Gnostici a Lefebvre, il lato
oscuro del Cristianesimo" Ed. Mondatori, 1996.
Ginzburg
Carlo, "Storia notturna – La decifrazione del sabba"
Ed. Einaudi, 1989.
Il
Manicheismo presupponeva infatti l’esistenza di un Dio del bene e
di uno del male, principi contrapposti nella cui lotta, attraverso
vari stadi, si attuava la salvezza dell’Uomo, con il trionfo del
bene. Si presentava come una fusione di elementi esoterici
tradizionali nelle più diffuse religioni orientali ed occidentali,
e tale fu la sua fortuna (Sant’Agostino stesso prima della
conversione ne fu ammaliato) che nei secoli successivi gli
eresiologi usarono battezzare ogni dottrina pseudodualistica con il
suo nome.
Manselli
Raoul, "L’eresia del male" Ed. Morano, 1963.
GLI ERETICI IN CASA NOSTRA: MONFORTE
O.V.
n.9 , Ottobre 2000
di Paolo Secco
Monforte, piccolo e
ridente paesino posto su una collina delle Langhe, è famoso per
produzione di ottimi vini e per l'originale auditorium ove si
svolgono applauditissimi concerti. Tutto potrebbero pensare i
turisti che ne riempiono la piazza, ma sicuramente non sono
consapevoli, per la maggior parte, della tragedia qui avvenuta
mille anni fa. Monforte non è un paese di cultura occitana, ma è
importante nella nostra storia in quanto, forse per la prima volta,
nell'Italia del nord -ovest si conobbero l'intolleranza e la
repressione violenta da parte dell'apparato ecclesiastico, che
diverranno poi nei secoli successivi la regola nel resto d'Europa ed
in particolare in Terra d'Oc. In questa località, all'inizio del
nuovo millennio, visse, inizialmente indisturbata, una comunità di
eretici, la cui dottrina si può definire vagamente precatara, fino
a quando tra il 1026 ed il 1028 subirono lo sterminio in gran
numero.
Due sono le fonti
storiche utilizzabili in questa strana vicenda: la prima è
rappresentata da Landolfo Seniore, cronista milanese dell'epoca; la
seconda, meno precisa e ben più esile, è data da quel Raoul
Glaber, o Rodolfo il Glabro, monaco borgognone, ed anch'esso
cronista, da noi già in precedenza conosciuto (2). Landolfo
Seniore, nel suo testo, descrive soprattutto le gesta
dell'Arcivescovo di Milano Ariberto D'Intimiano, che avrebbe, in
ultimo, fatto espugnare il castello di Mons-Fortis/Monforte. Così
cita la fonte: "In quel tempo Ariberto giunse a Torino
accompagnato da una schiera di buoni chierici e da una truppa di
valorosissimi guerrieri (...) sentì parlare di una non ancora udita
eresia, che da alcun tempo si era manifestata nel castello sopra la
località detta Monte Forte. Avendo udito ciò, ordinò subito che
da quel castello gli venisse condotto un uomo di quell'eresia, per
meglio conoscere la questione". Il racconto prosegue poi con il
colloquio intercorso tra il vescovo e un tal Girardo o Gerardo,
presumibilmente capo di questa comunità di eretici, e con il
conseguente invio delle truppe di Ariberto allo scopo di catturare
quanti più eretici fosse possibile, e tra questi la contessa di
quel castello, anch'essa fortemente eterodossa. Condotti a Milano,
ai prigionieri fu lasciata la possibilità di rinnegare la propria
fede e salvarsi dall'esecuzione, ma, a quanto si dice, la maggior
parte scelse volontariamente il rogo.
Sarebbe a questo punto
importante capire chi fossero realmente questi eretici, così
pericolosi agli occhi della Chiesa. Questo duro attacco
“inquisitoriale” precedette, con pochissimi altri sporadici
casi, di quasi due secoli quella che sarà una vera guerra di
religione, la cosiddetta Crociata contro gli Albigesi, o Catari,
iniziata da Innocenzo III° nel XIII° secolo, i Catari, all'epoca
non erano infatti ancora conosciuti come tali, ne tanto meno
temuti. Abbiamo visto in precedenza che tutti i movimenti ereticali
fino ad allora sviluppatisi venivano definiti genericamente
Manichei, senza troppo preoccuparsi delle distinzioni dogmatiche.
Perché allora un gruppo di abitanti di un borgo essenzialmente
rurale, sottoposti al Vescovo di Asti, e quindi gerarchicamente
all'Arcivescovo di Milano, ma distanti comunque da questi ben 150
km, persone che probabilmente per la loro peculiarità religiosa
evitavano contrasti con i poteri vicini, furono oggetto di una così
intransigente e severa repressione?
La risposta sta forse
proprio nelle parole di Landolfo Seniore, quando descrive, seppur
con un certo sentimento di parte, (non dimentichiamo infatti che il
nostro era quasi sicuramente cronista al soldo dell'Arcivescovo) la
dottrina esposta dall'eretico Gerardo in occasione
dell'interrogatorio subito.
Alle prime domande
rispose equivocamente, per far credere forse alla sua ortodossia,
poi preso forse coraggio, incalzato da richieste di precisazioni,
non esitò ad esporre nei particolari le sue credenze,
caratterizzate da un’interpretazione essenzialmente spiritualista
data alle Sacre Scritture, alla Trinità, al concetto di Spirito
Santo (3). La comunità aveva poi alla sua testa un gruppo di
"Maiores" (i Perfetti Catari?), e primo fra tutti, un
pontefice, ovviamente non identificato in quello romano, che giorno
per giorno visitava i fedeli; figura questa che può forse essere
interpretata in modo simbolico, rappresentando esso lo Spirito
Santo, che , donando la cognizione della scienza divina, libera
l'uomo dalle sue colpe.Tutto ciò sembra pertanto escludere ogni
nozione dei Sacramenti, di cui peraltro Gerardo rifiutò di
parlare. Da tale spiritualismo deriva così un moralismo esasperato,
un rifiuto della materia, della proprietà, di ogni istinto carnale.
Inconfondibile nota distintiva di questa nuova eresia era
l'accettazione di una morte violenta, colma di sofferenza, tale da
portare, con la purificazione, alla salvezza. E' difficile capire se
si può accostare tale concetto a quello dell' "Endura"
catara, di cui parleremo in seguito, sta di fatto che tutta questa
dottrina così fortemente innovativa e destabilizzante, non potè
che creare timori sociali, oltre che religiosi, nelle autorità,
consce del fatto che i nostri eretici, condotti a Milano, non
esitavano a parlare alla popolazione, nella speranza di fare
proseliti.
Se la maggior parte
degli studiosi di movimenti ereticali sorvola sui reali motivi che
portarono al rogo i nostri protocatari di Monforte, collegandoli
alle vicende di Orlèans e di Arras, di cui abbiamo parlato, una
suggestiva e molto intuitiva interpretazione ci viene dal romanzo di
un giovane scrittore originario della zona, Maurizio Rosso, (4)
narrazione che nasconde in realtà un vero saggio sull'argomento da
noi trattato. La sua ipotesi è che la tragedia occorsa sia il
frutto di una scelta militare/politica da parte dell'autorità
predisposta al controllo della zona, scelta in cui i motivi
religiosi spariscono del tutto.
Alla morte di Ottone
III° e di Enrico II°, estinta, a capo del Sacro Romano Impero,
la dinastia di Sassonia (1024), il potere passa nelle mani di
Corrado II° il Salico, che tra il 1026 ed il 1027 scende in Italia
per ricevere l'incoronazione dall'Arcivescovo Ariberto, con il
proposito di recarsi quindi a Roma dal Pontefice. Ma sorge un
problema, in quanto giunto ad Asti per continuare il suo viaggio
verso Tortona e la Via Postumia dovrebbe passare in territorio
ostile, controllato da Bonifacio di Canossa.
Molto meglio allora
servirsi di una strada un po' particolare, di cui si è oggi persa
ogni traccia, denominata da alcuni studiosi (5) "Via Magistra
Langarum", che salendo da Alba sull'alta Langa, attraversandola
per creste, scendeva poi in Liguria collegandosi alla Via Aurelia.
Era un percorso sicuro, in territori controllati da Arcivescovi e
nobili amici, ma con un solo peraltro piccolo intoppo: il castello
di Monforte abitato dai nostri eretici, ovviamente considerati
potenziali nemici. Si potrebbe così pensare che Ariberto ed
Alrico, Vescovo di Asti, si siano per così dire premuniti, per
evitare in anticipo ogni inconveniente.
Fu comunque una vicenda
che in qualche modo fece scalpore, almeno a Milano, ove avvenne
l'esecuzione, e lasciò il segno nel nome di un borgo della città
(Borgo Monforte).
“Landulphi Senioris
Mediolanensis Historia"
(2) Raoul Glaber,
"Cinque libri di storia dei suoi tempi"
(3) Raoul Manselli,
"L'Eresia del male" Ediz. Morano, Napoli 1963
(4) Maurizio Rosso,
"Mons Fortis – Il castello dei Catari" Ediz. Gribaudo,
Cavallermaggiore 1996
(5) Donato Bosca, "I
paesi senza storia – costume e vita medioevale nella langa
contadina" Ediz. Gribaudo, Cavallermaggiore
"Dicuntur Catari a cato" ... sono
detti Catari da gatto
O.V.
n.10, Novembre 2000
di Paolo Secco
Tutti i vari moti di
contestazione della chiesa che nella prima metà del XII° secolo
erano divampati in Europa si erano anche rapidamente spenti, sia
perché forse troppo istintivi e tumultuosi, come quello dei
Patarini a Milano, e comunque troppo circoscritti, sia per la
mancanza di una vera dottrina alternativa da proporre e, molto
spesso, per la pochezza di una ricerca teologica che potesse
attirare gli spiriti più evoluti. Prima ancora però che questi
moti sfiorissero, anche a causa della dura repressione, iniziò a
serpeggiare per le terre d'Europa un nuovo tipo di contestazione,
più radicale, più carica di significati, un rifiuto pressoché
totale di tutta l'istituzione ecclesiastica, con i suoi valori e
concetti. Aveva così inizio una nuova visione del cristianesimo.
Non si trattò di una setta o di una elite intellettuale, ma di un
movimento spontaneo, che affiorò contemporaneamente in punti
diversi del continente, ove, spesso, le condizioni storico –
sociali permettevano più libertà ed evoluzione di pensiero. Ne era
fondamento una semplicissima e perfino banale constatazione: il
mondo terreno appariva, ad un attento esame, il regno del male,
dell'ingiustizia, delle sofferenze e della corruzione, non poteva
pertanto essere evidentemente emanazione di un dio buono, ed era di
conseguenza necessario rimanerne fuori, isolandosi nella pratica di
retti principi morali, in attesa della liberazione, portata dalla
morte. Come era avvenuto in passato per quasi tutti i movimenti
eterodossi, dapprima i nuovi eretici furono scambiati per gli ormai
noti manichei del passato, a causa di un preciso fondamento
dualistico nella loro dottrina, che evidenziava nettamente il
contrasto fra Bene e Male. Da tutti gli studi svolti non è peraltro
risultata nessuna traccia o eredità evidente del pensiero della più
antica eresia del IV° secolo. La nuova eresia si presentò, in modo
ben documentato, almeno dal punto di vista delle fonti
ecclesiastiche, a Bonn e Colonia nel 1144: l'abate Everwin di
Steinfeld ne diede notizia al già famoso Bernardo di Chiaravalle,
descrivendo tali eretici come pericolosi individui che rifiutavano
qualsiasi sacramento, negavano in toto l'autorità della Chiesa e
prendevano in considerazione come unica preghiera il Pater,
ovviamente recitato in modo differente. Bernardo ricevette notizie
di tal tenore anche da altre località; il vescovo di Beauvais
denunciò infatti la presenza di simili eretici nella Francia
meridionale. Bernardo si recò immediatamente sul posto ma a Tolosa
ed a Albi si trovò ben presto a mal partito Di questo periodo
parla anche uno dei primi testi che conforteranno e supporteranno
in un futuro vicino le autorità ecclesiastiche nei processi
inquisitoriali: il “Tractatus de haereticis” del frate Anselmo
di Alessandria, scritto in epoca più tarda. Negli anni a seguire
vennero denunciati ed infine condannati al rogo presunti eretici in
grande quantità, nel 1147 a Perigueux nella Francia centrale, nel
1163 a Colonia, ove esisteva un gruppo proveniente forse dalle
Fiandre, che dichiarò, nello svolgersi del processo, la propria
qualità di “Buoni Cristiani”. Tale era la forza spirituale di
questi uomini, e tale la loro coerenza, che non esitavano a
contrastare, spesso in pubblico, i religiosi del luogo, spingendoli
ad un dibattito serrato nel corso del quale a tutti diventava
evidente la loro profonda conoscenza delle scritture e la grande
dialettica. Ciò accadde ad esempio nel 1165 a Lombers, in
Linguadoca, ove era riunito un sinodo di vescovi, alla presenza tra
l'altro del Conte Raimondo di Tolosa, del Visconte Trencavel di
Béziers, che già in questa occasione si dimostrarono perlomeno
influenzati da queste nuove dottrine. In quegli anni, in vari
processi, specialmente in Germania, questi eretici cominciarono ad
essere denominati con quello che rimarrà poi definitivamente il
loro nome: Catari. “Catharos, id est puros” (Catari, cioè puri)
scriveva tra il 1152 e il 1156 Ecberto di Schonau nei suoi “Sermones
adversus Catharorum errores”, rifacendosi ovviamente al relativo
termine greco Katharos. Ma tra il basso clero, ignorante ed
evidentemente poco ferrato negli studi classici, e tra le
popolazioni, divenne d'uso un'interpretazione assai diversa.
derivata da un'etimologia fantasiosa, ripresa poi, sul finire del
secolo, dal frate Alano da Lilla: “Dicuntur Catari a cato” –
sono detti Catari da gatto – in quanto si credevano, secondo le
credenze popolari, ovviamente ben stimolate dal clero, usi baciare
il posteriore del felino simbolo del diavolo, nel corso dei loro
riti segreti. Sta di fatto che tale fu la loro diffusione e la loro
fama che nella lingua tedesca il vocabolo Ketzer rimase ad indicare
genericamente l'eretico, e Ketzerei l'eresia. In altri casi, come a
Reims nel 1162, in occasione di un processo, compare il nome
“Pobliciani”che ricorre altrove nella forma “Populiciani”.
E' questa forse l'occasione per riconoscere i legami del Catarismo
con un movimento religioso un po'più antico, ma allora ancora ben
vivo nella Penisola Balcanica ed in Bulgaria. La parola Pobliciani
sembra essere la corruzione di Pauliciani, nome di una setta sorta
in Armenia nel VII° secolo, i cui adepti si autodefinivano Figli di
Paolo, in quanto unici e veri continuatori del pensiero e dell'opera
di Paolo di Tarso, il famoso San Paolo. Cacciati dall'Armenia si
erano poi stabiliti in Tracia e da lì nei paesi vicini, dando vita,
probabilmente, in Bulgaria, ad una loro emanazione: i Bogomili, così
chiamati dal nome di un loro Pope, Bogomil. Anche costoro seguivano
una sorta di dottrina dualistica, attribuendo a Satana la creazione
del mondo terreno, visibile. Praticavano una vita ascetica ed
un'opposizione dura al centralismo politico – religioso di
Bisanzio. Erano stati per questo sovente perseguitati,
dall'imperatrice Teodora, da Basiglio e da altri, ma ciò
nonostante erano ancora presenti, in particolare in Bosnia, ove
erano protetti dai potenti del luogo. La stretta parentela fra
Catari e Bogomili è evidente se in effetti si paragonano le
rispettive dottrine, ne è prova tra l'altro un vangelo bogomilo,
portato dalla Bulgaria forse in Italia da un cataro attorno al 1190,
e da qui finito poi in Linguadoca (1). Di massima importanza fu il
primo grande concilio cataro che si tenne a Saint – Félix de
Caraman, presso Tolosa, nel 1167, al quale partecipò in qualità di
presidente dell'assemblea il Pope Bogomilo Niceta, che parlò a
lungo della sua chiesa e dei rituali, influenzando in tal modo
l'organizzazione futura delle chiese catare di Albi e d'Italia. Si
possono pertanto riconoscere come importanti le affinità dottrinali
e rituali fra le due eresie, ma bisogna tener conto che tali
movimenti dualistici si sono sviluppati quasi contemporaneamente dal
vicino Oriente fino alla Francia, e pertanto alcuni autori moderni,
in particolare Anne Brenon (2), considerano la filiazione
Bogomilo-Catara molto meno evidente di quanto sia apparsa in
passato. Precisa la Brenon che “furono piuttosto sia gli uni (i
Catari) che gli altri (i Bogomili) figli di un medesimo movimento
storico, eredi senz'altro di un'unica tradizione”.
(1) “Interrogatio
Johannis Apostolis” (Tribunale dell'Inquisizione, Tolosa).
(2)
Anne Brenon, “Le vrai visage du Catharisme”, Toulouse, 1988.
Trad.Italiana : “I Catari, storia e destino dei veri
credenti” Ed. Convivio, 1991. Altri testi riportanti la questione:
H. C. Puech, “Sul manicheismo e altri saggi” Ed. Einaudi, 1995,
vedi capitolo “Catarismo medioevale e Bogomilismo”; Lidia Floss,
“I Catari, gli eretici del male”, Ediz. Xenia, 1999; Grado G.
Merlo, “Eretici ed eresie medievali” Ed. Il Mulino, 1989.
I casi di Pietro di Bruis e di Roccavione.
Gli eretici e le montagne
O.V.
n.2 , Febbraio 2002
di Paolo Secco
E’ a tutti noto che
alcune valli delle Alpi occidentali hanno per secoli costituito
rifugio per comunità e gruppi cristiani non cattolico–romani. In
particolare le valli Pellice, Chisone e Germanasca hanno assunto
nel tempo il nome di Valli Valdesi. Ma mentre per queste comunità
è più facile portare avanti un discorso storico, per i gruppi
eterodossi presenti nel resto delle Alpi occidentali ci si può
riferire esclusivamente alle fonti originarie, quasi sempre di parte
cattolica. In quasi tutte le fonti è difficile distinguere le
differenze dottrinali fra i vari gruppi ereticali presenti sulle
Alpi e nella pianura. Spesso con il nome di “Valdenses” vengono
indicati gruppi diversi. Del resto, nell’esposizione della propria
dottrina da parte di alcuni accusati nei processi inquisitoriali è
ben evidente un vero e proprio sincretismo religioso. Ne è un
esempio la vicenda svoltasi in Monforte, nelle Langhe, nei primi
decenni dell’anno mille, che abbiamo ampiamente trattato in una
puntata precedente.
Molti studiosi si sono
occupati del passaggio attraverso le Alpi di gruppi o individui
Albigesi in fuga dalla dura repressione nel sud occitano del XIII°
secolo, in direzione della “Lombardia”, corrispondente a quei
tempi all’ ovest della Pianura Padana. E’ noto come ancora nei
secoli successivi il nord Italia fosse considerata terra di
tolleranza religiosa: “In Lombardia non fit malum hereticis,
iudeis et sarracenis” (1). Le Alpi, per dirla con le parole di
Grado G. Merlo (2), furono relegate, da molti storici, al rango di
accidente geografico, dal duplice volto di divisione e di protezione
lungo itinerari i cui punti di partenza ed arrivo stavano altrove.
Rimangono comunque senza
risposta una serie di domande: quando si diffonde l’eresia nelle
Alpi? Con quali caratteri originari? Una prima fonte che merita
un’attenta considerazione è il “Tractatus contra Petrobrusianos
hereticos” di Pietro il Venerabile, famoso abate di Cluny,
collocabile negli anni trenta del XII° secolo, quando ancora poco
si parlava di Catarismo. In due lettere, che assumono appunto forma
di trattato, indirizzate ai vescovi di Embrun, Die e Gap, l’abate
cluniacense tenta di fornire uno strumento teologico–dottrinale
per contrastare gli effetti della predicazione di un ex prete,
Pietro di Bruis, che per decenni aveva portato in lungo ed in largo
pericolose dottrine eterodosse. L’eretico, originario delle
Hautes–Alpes, forse di un villaggio nei pressi di Rosans, aveva
dapprima predicato nei luoghi di origine poi, cacciato a seguito di
una dura repressione, aveva visitato la Provenza, arrivando con le
sue teorie fino alle lontane terre di Guascogna, e varcando, secondo
alcune fonti, anche le Alpi. Era finito poi sul rogo nei pressi di
Saint Gilles, attorno al 1133 o, secondo alcune fonti, nel 1139.
Resta il fatto che la zona di influenza delle idee petrobrusiane
andava ben al di là della terra di origine, anche perché esse
rappresentavano un bisogno di semplificazione, di ritorno al
cristianesimo originario, una necessità di purezza ideologica e
materiale presente nelle popolazioni di ogni regione. L’abate di
Cluny lamentava che, essendo egli stesso transitato per la
“Provincia Septimanie seu Alpium Maritimarum” si era accorto di
persona di quanto ivi perdurasse “Erroneum Dogma”, nonostante
l’espulsione dalla zona dei principali “auctores”. Pietro il
Venerabile aveva dapprima pensato che l’influenza di tale dogma
dipendesse principalmente dalla mentalità e dai costumi “agrestes
et indocti” di uomini abituati a vivere isolati sulle montagne,
fra boschi e valli sperdute, lontani, a suo dire, da ogni apporto
culturale. Ma rendendosi poi conto con stupore che l’eretico in
questione aveva lasciato il segno anche nella società più
urbanizzata del midì francese, fu costretto a cambiare opinione e
ad approfondire ciò che stava dietro alla predicazione dell’eretico
frate..
Pietro di Bruis non fu
Cataro, e nemmeno precursore del Valdismo, ma piuttosto fu l’esempio
di quella chiesa spirituale conseguenza della riforma attuata nell’
XI° secolo; sta di fatto che in Delfinato, sulle Alpi, agli inizi
del XII° secolo nacque un movimento eretico che non rimane
esclusivamente locale. Nulla dice peraltro il “Liber contra
Petrobrusianos” sulla propagazione di tale idee sul versante
alpino piemontese, ma è facile individuare alcune sicure
corrispondenze con posizioni culturali, liturgiche, dottrinali,
espresse più tardi da alcuni eretici piemontesi nel corso di molti
processi d’inquisizione. E’ possibile parlare pertanto di
continuità? L’elemento comune sembra costituito da una
religiosità scarna ed essenziale, che presuppone un rapporto
diretto con Dio. Parliamo ora di alcuni dei pochissimi documenti
che prendono in considerazione la circolazione ereticale nel periodo
compreso fra la morte di Pietro di Bruis e la caduta di Montségur,
nel 1244. Attorno agli anni ’60 - ’70 del ‘200, l’inquisitore
Anselmo di Alessandria ricostruisce nel suo “Tractatus de
hereticis” le origini del Catarismo in occidente, e, fra le tante
notizie, riporta la vicenda di quattro milanesi che, attorno alla
metà del XII° secolo, convertiti alla nuova fede da un “notarius
de Francia”, vengono da questi inviati a Roccavione, ove i Catari
erano venuti ad abitare direttamente dalla Francia. In effetti già
all’epoca, ben prima della metà del XII° secolo, sono
attestate violenze antieterodosse al di là delle Alpi, ed è
pertanto possibile che molti fossero già allora in fuga alla
ricerca di un posto tranquillo. Il nome di Roccavione risulta già
documentato a quei tempi, il paese era d’altra parte situato alla
confluenza di più vie di comunicazione, fra cui il Colle di Tenda
(3). La località era facilmente raggiungibile, ed era oltretutto
vicina a Cuneo, ove più tardi, attorno al 1240 – 1260, sono
accertate presenze catare. Dal Tractatus sembra addirittura che
all’epoca in Roccavione vivesse un “Episcopus”, che però al
momento dell’arrivo dei milanesi si trovava in visita a Napoli,
città ove i nuovi arrivati lo avrebbero presto raggiunto. Per
alcuni storici (Borst, Manselli) la notizia è degna di fede, per
altri invece (Dupré, Theseider) il racconto di Frate Anselmo
presenta elementi leggendari, ancorché non inverosimili, ma
soprattutto riflette una situazione posteriore.
(1) Registro di
Inquisizione di Jaques Fournier, Vescovo di Pamiers . (1318 –
1325)
(2) Grado G. Merlo, “Eretici ed inquisitori nella
società piemontese del ‘300” Torino, Ed. Claudiana,
(3)
Comba Rinaldo, “Strade e mercati dell’area sud occidentale. Per
una storia economica del Piemonte medievale” BSS. Torino, 1984.
“Ad explorandum ibi hereticos”. Eretici a
Cuneo e Bernezzo tra ’200 e ’400
O.V
n. 3, Marzo 2002
di Paolo Secco
“Queste
nostre valli negli anni fra la fine del 1100 e la seconda metà del
1200 sono state teatro di una delle più grandi trasmigrazioni di
perseguitati religiosi di tutto il medio evo.” Con queste parole
Aldo Alessandro Mola, in un suo articolo, presenta la situazione
della montagna occitana nel periodo in questione. I Catari qui
arrivati non avevano ovviamente alcun minimo interesse a farsi
notare troppo, il loro stile di vita rimase, per così dire, di
basso profilo, cercarono anzi in molti casi l’integrazione con le
popolazioni locali, facilitati anche dalla comunanza della lingua.
Più
facile invece è trovare qualche notizia nelle città, ove
l’attività delle autorità inquisitoriali fu sicuramente più
vasta e documentata. Si legge fra l’altro di un certo Pietro di
Beuila, di Avignone, a lungo vissuto nell’allora Lombardia,
tornato a casa ed imprigionato nel 1278 che, sotto interrogatorio,
racconta di aver abitato, trent’anni prima, per ben sette anni a
Cuneo, ospite di correligionari, e di aver lì incontrato numerosi
fedeli Catari provenienti da Tolosa, da Moissac e da altre zone
devastate dai crociati. Fra questi un certo “Bertrandus de
Avinione fugitivus”, che qui viveva proprio grazie ai denari avuti
per l’occasione dai signori di Tolosa. Rientrava sicuramente nella
politica della nobiltà della Francia meridionale coprire e
finanziare i propri dissidenti, almeno quelli più conosciuti,
favorendone il passaggio in terre meno pericolose, in modo da
assicurare la continuità dell’idea centrale attorno alla quale si
era da poco svolta la pagina più drammatica della storia delle
province occitane, passate dalla squisita civiltà e cultura
trobadorica agli orrori della guerra e al dominio della rozza e
incolta nobiltà nordica.
Negli
anni successivi alla presa di Montségur (1244), i fuggiaschi
divengono un flusso continuo ed ampio, ricco di conseguenze sul
piano politico-economico nello sviluppo dei comuni padani. Cuneo,
sorta nel 1178 allo sbocco delle valli alpine, diviene fra il 1243 e
il ’58 un centro attivo dell’eresia catara. Ricorre il nome di
un tale “Aldricus, filius Raimundi de Caramano”, che afferma di
essere venuto con alcuni compagni di fede ad “Achonium”, ovvero
Coneum – Cuneo, per ripartire dopo poco tempo in direzione di
Alessandria e di Pavia, da cui più tardi ritornò, sempre passando
per Cuneo, in Occitania francese. Questa situazione di tolleranza è
dovuta, sembra, alla protezione loro accordata dalla ricca
borghesia locale, che vede di buon occhio i rapporti che i Catari
intrattengono con altre città della pianura, e non solo per motivi
economici, ma soprattutto per l’orientamento politico che alcune
città della Padania rappresentavano.
Non
è affatto casuale che mentre cresce il potere politico-economico
della borghesia i Catari siano lasciati liberi di professare il loro
culto, con l’unico limite della salvaguardia dell’ordine
pubblico. Cuneo riveste a quei tempi la qualifica di libero comune,
piccola Villa aperta ai rifugiati e ai dissidenti religiosi.(1). Nel
1258 i nuovi statuti cercano di limitare l’influenza in città
dell’Abate di Borgo S. Dalmazzo: in pratica i Cuneesi decidono di
rifiutare il pagamento delle decime, dei pedaggi e di tributi vari,
sottraendosi così al potere del clero locale. Il Vescovo
ovviamente non può che rispondere chiedendo soccorso, e dichiarando
la città di Cuneo “ribelle”(2). Tutto ciò ebbe fine dopo il
1259, quando un trattato consegnò la città nelle mani di Carlo
d’Angiò, marito di Beatrice, figlia di Raimondo Berengario di
Provenza, che nell’Occitania francese, già martoriata dalla
crociata contro gli Albigesi, si era distinto per la severità
contro gli eretici di ogni tipo. Carlo d’Angiò riprese infatti
poco dopo, nel 1264, prima di essere incoronato Re di Napoli dal
Papa, le sue persecuzioni in Provenza e al di qua delle Alpi.
È
forse in questo periodo che si può ipotizzare uno spostamento degli
eretici sulle montagne, nelle valli più inaccessibili e meno
esposte a visite degli uomini di chiesa. Il d’Angiò nel 1269
scrive al Papa chiedendo aiuti per gli inquisitori nelle terre di
Francia e domanda che ne vengano mandati anche in “Lombardia”,
tra cui Cuneo, “ad explorandum ibi hereticos”.
Carlo
in realtà era fautore di uno stato sostanzialmente laico e
autonomo. Non era pertanto interessato all’aspetto religioso della
dissidenza, ma voleva evitare problemi con comunità troppo
indipendenti.
In
qualche caso gli eretici furono condannati e bruciati sui roghi
solo quando rappresentavano un simbolo di libertà di fronte agli
occhi di tutti. Negli altri casi invece moltissimi furono i Catari
condannati a pene pecuniarie o all’esilio.
E’
questo il motivo per cui nei secoli successivi il Catarismo, nelle
sue forme ed evoluzioni diverse, continuò comunque ad esistere,
seppur nell’anonimato, nelle terre del cuneese. Circa due secoli
dopo, infatti, verso i primi anni del ‘400, una comunità in cui
esistevano eretici, Bernezzo, paga una pena di milleduecento
fiorini, somma enorme per l’epoca, a Ludovico d’Acaja, in
quanto “incolpabantur plures hereses facisse et plura mala contra
fidem catholicam comisisse”(3).
Fra
il 1441 ed il ’42 i frati inquisitori Bernardo Pietro e Lodovico
Socino procedono di nuovo contro la comunità di Bernezzo: ventidue
eretici considerati “relapsi”, ovvero recidivi, vengono
trascinati a Cuneo e bruciati sul rogo. E’ da notare come vengano
chiamati “Gazari”, sinonimo di Catari. I loro beni furono
ovviamente confiscati, senza che però nulla ne venisse al comune di
Cuneo, con gran dispetto dell’allora esattore Lorenzo Rabacino che
su questa questione lasciò alcune annotazioni nei suoi resoconti
ufficiali delle imposte (4). Capitò allora che gli abitanti di
Bernezzo, sentendosi a torto o a ragione alquanto perseguitati,
ricorressero alla protezione del papa Callisto III° contro gli
inquisitori.
Gli
Stati Generali del 1478 si pronunciarono violentemente contro le
esagerazioni e la severità assurda di questi frati, chiedendo che
si provvedesse affinché ad essi fosse sempre in futuro affiancato
un certo numero di cittadini fidati, affinchè non venisse
oltrepassato il limite del diritto vigente. Ciò permise comunque di
lasciare nei secoli il segno di una cultura religiosa poco incline
alle rigidità della dottrina ufficiale, ed aperta a futuri influssi
di altre fedi eterodosse.
(1)
A) Giuseppe Boffito Giuseppe, “Gli eretici di Cuneo” in BSBS
n.VI°, 1896. B) Ferdinando Gabotto, “Roghi e vendette.
Contributo alla storia della dissidenza religiosa in Piemonte prima
della Riforma”, Pinerolo, 1898. C) Piero Camilla, “Cuneo
1198 – 1382” BSSSAA Provincia di Cuneo, Cuneo, 1970.
(2)
Deliberazione del Capitolo dei Monaci. 14 IX 1258.
(3)
“Erano stati incolpati di numerose manifestazioni ereticali e di
aver commesso molte male-azioni contro la fede cattolica” Ne
parlano Boffito e Gabotto (vedi nota 1) riferendosi ad un anonimo
“Cronicon” della città di Cuneo.
(4)
In quella che è considerata la prima cronaca di Cuneo l’avvenimento
viene raccontato, senza alcun commento, da Giovanni Francesco
Rebaccini (?), figlio forse di quel Lorenzo Rabacino, già citato,
esattore all’epoca dei fatti.
Tholozan, Narbona, Catalenh, Pra’ de Boni...
L’eresia nei toponimi delle Valli Occitane
O.V.
n.4, Aprile 2002 di
Paolo Secco
Dopo
aver affrontato nelle puntate precedenti la presenza dell’eresia
nelle nostre valli vogliamo ora parlare di quanto può essere
rimasto di queste presenze nella memoria e nella cultura delle
popolazioni locali, e di quanto può risultare da toponimi, nomi di
famiglia, usanze. In mancanza di fonti scritte, sia ufficiali che di
privati, dobbiamo però limitarci alle ipotesi, nella speranza che
qualche lettore voglia intervenire con suggerimenti, nuove ipotesi o
correzioni.
Il
primo esempio che può in qualche modo far pensare alla presenza di
Catari nelle nostre valli è il nome Tolosa, presente nei cognomi
Tholosa, Tholozan, Tolosano, e, come toponimo, nel comune di
Marmora (valle Maira), ove esiste una borgata Tolosano. Sappiamo che
dopo la caduta di Montségur, nel 1244, molti linguadociani
fuggirono dalle violenze della crociata. Molti dalle città si
rifugiarono in località appartate, la maggior parte cercarono
scampo in terre lontane, alcuni in Lombardia, come allora veniva
denominata l’Italia settentrionale, ove preesistevano gruppi
organizzati di eretici. E’ probabile che, nel lungo cammino, molte
famiglie si siano fermate in località delle Alpi occidentali, dove
le condizioni promettevano un futuro più tranquillo. D’altra
parte i paesi ove compare il nome Tholosa o Tholozan sono vicini a
valichi già frequentati all’epoca, come il Colle della Maddalena
in valle Stura e quelli del Sautron e del Maurin in val Maira.
Errato
sembra essere invece l’accostamento all’eresia del nome di una
piccola borgata ormai disabitata della Valle Grana, Narbona, poiché
il toponimo, nella parlata locale, risulta essere L’Arbouna, con
tutt’altri riferimenti eccetto quello alla famosa città del sud
occitano (1). Il nome locale è sicuramente più affidabile dal
punto di vista della nostra indagine, e la trasformazione subita
nell’italianizzazione potrebbe essere dovuta a semplice ricerca di
semplificazione da parte di funzionari dello Stato.
Esiste
peraltro un caso particolare di toponomastica che può attirare la
nostra attenzione: in quel di Saliceto, paese dell’alta Langa ai
confini dell’area piemontese con quella ligure, al di fuori
comunque dell’area occitana, esiste una frazione denominata
Catalani. Ho incontrato questa informazione leggendo un bel romanzo
di uno scrittore locale, Guido Araldo (2), che di questa frazione è
originario. Da Araldo ho potuto appurare che la denominazione locale
è Cataran, che può far pensare a presenze Catare, e fu
italianizzata in Catalani, a suo dire, da geografi fiorentini
incaricati di registrare la toponomastica locale. Esiste peraltro,
proprio nella zona del paese, una montagna il cui nome, non citato
sulle carte, è Jan Pèire, denominazione che poco ha a che vedere
con l’area culturale linguistica piemontese-ligure della zona, e
che pertanto si potrebbe pensare come importata. E’ facile a
questo punto pensare all’insediamento di eretici provenienti
dall’Oc-citania, ma resta difficile capire, senza documentate
fonti storiche, come questi si siano insediati proprio in una
località molto vicina ad una grande via di comunicazione
dell’epoca, la Via Magistra Langarum di cui già abbiamo parlato
(3), frequentata fra l’altro anche per pellegrinaggi, con il
pericolo di essere scoperti. Sembra peraltro documentato l’arrivo
nel porto di Oneglia (Imperia), nel periodo successivo alla crociata
contro gli Albigesi, di profughi forse Catalani, probabilmente
Catari. E’ però opportuno in questo caso usare la massima
cautela nel dare un senso storico alla vicenda.
Una
situazione quasi identica si presenta nella zona di Boves, ove
esiste una borgata Catalenh (4). Anche in questo caso non si hanno
notizie né memorie recenti. Ovviamente non ha molto senso parlare
di presenze Catalane nella zona. Pure qui ogni ipotesi è aperta.
Per non allontanarci troppo, problema simile è stato posto in un
recente libro sulla Bisalta (5) in cui viene fatto un esaustivo
esame della cultura, della storia, della fauna e della flora nelle
valli attorno a questa imponente montagna. Tomaso Cavallo, di
origine peveragnese, in un breve capitolo dedicato a Pradeboni,
arrischia un’ipotesi sull’origine del paese: Pra’ de Boni, non
può essere sicuramente fatto risalire alla fertilità o alla bontà
dei terreni, fa piuttosto pensare a dei “Boni” intesi come
famiglia, o a un qualche gruppo di Boni Homines medioevali, ovvero,
guarda caso, ai nostri amici Catari. L’autore sa benissimo di fare
una congettura assolutamente azzardata, ma d’altra parte, quando
le fonti storiche non supportano, è bello usare la fantasia, con la
dovuta consapevolezza, immaginandoci lontane origini. Anche qui
siamo vicini ad una via importante di comunicazione, il Col di
Tenda, ma nello stesso tempo siamo appartati e nascosti dalle
pendici della Bisalta. Tutto sarebbe perfetto (scusatemi
l’involontaria ironia!) se non fosse che l’area di Pradeboni
quasi sicuramente all’epoca era sotto l’influenza, se non di
proprietà, della Certosa di Pesio, fondata nel 1173 con una
donazione dei consignori di Morozzo ai frati certosini. Del resto
la Valle Pesio e le zone vicine sono forse le uniche in cui non si
ha traccia documentata di presenze ereticali nel periodo che va dal
XII° al XIV° secolo, e i roghi di cui si hanno notizie in
Peveragno nel XIV° secolo e nel seguente si riferiscono
probabilmente a gruppi di origine valdese.
Facciamo
ora un balzo verso Bellino, in Val Varaita. Un libro non recente di
Jean Luc Bernard (6) analizza, fra i molti altri aspetti della
cultura del paese, l’aspetto religioso nella vita della comunità.
Contrariamente ai montanari delle valli vicine, i Bellinesi non
conoscevano l’allevamento del maiale, e non utilizzavano, se non
eccezionalmente, prodotti di origine animale, ad eccezione del
latte. Non sembra essere un aspetto dettato dalla povertà, quanto
piuttosto una vera e propria forma di alimentazione vegetariana. Non
erano inoltre conosciuti procedimenti di concia delle pelli, né di
conservazione della carne. Alcuni atteggiamenti nella vita di tutti
i giorni sembravano rifarsi in effetti, anche se molto alla lontana,
alla cultura dualistica dei Catari; mi riferisco, sempre seguendo le
orme del Bernard, all’estrema discrezione delle donne in stato
interessante, alla concezione fatalistica nell’accettazione delle
avversità, anche le più dure. Viene da pensare all’atteggiamento
della cultura catara, ove l’individuo si sentiva in balìa di Dio,
o meglio del Diavolo, ma con una sorta di forza interna, dovuta alla
consapevolezza di essere in qualche modo privilegiato, in quanto
comunque consapevole delle proprie possibilità di salvezza. Sono
tutti piccoli particolari, insignificanti forse di per sé, ma
importanti se considerati nel loro insieme. Il primo parroco a Blins
sembra esser arrivato attorno al 1380. Che ne è, dal punto di vista
religioso, dell’epoca precedente?
(1) Novel Temp n°18, R. Lombardo,
“Appunti sulla peculiarità del dialetto occitano di L’Arbouna”
(2) Guido Araldo, “Prèscricia –
La pietra scritta” Editoriale Le Stelle, Millesimo, 2000.
(3) Ousitanio Vivo n°249, ottobre
2000, “Gli eretici di casa nostra: Monforte”
(4) Fonte: Fausto Giuliano di
Boves/Rivoira.
(5) Tomaso Cavallo, “Pradeboni,
rifugio dei Catari” in: “Bisalta, una grande montagna” AAVV a
cura di N. Villani, Ediz. Primalpe – Blu, Peveragno 2000, pagg.
70-71.
(6) Jean Luc Bernard, “Nosto modo –
Testimonianze di civiltà Provenzale Alpina a Blins” Ediz.
Coumboscuro, Busca, 1992.
Quaderni
C.I.P.E.C.
n.
1, aprile 1995
Lucia
Canova, donna e comunista
Il
PSIUP in provincia (Sergio Dalmasso)
n.
2, ottobre 1995
Chiaffredo
Rossa, scalpellino
La
nuova sinistra nella provincia bianca (Sergio Dalmasso)
Bibliografa
sulla sinistra cuneese (Carlo Giordano)
n.
3, novembre 1995
Maria
Capello, la ragazza rossa (Cetta Berardo)
Testimonianze
di Carlin Petrini e Sergio Dalmasso
Bra
fra slanci rivoluzionari e reazione fascista (Livio Berardo)
n.
4, luglio 1996
Le
vicende elettorali delle forze politiche cuneesi (1945/1996)
Tabelle,
grafici, saggi introduttivi di Felice Paolo Maero e Sergio Dalmasso,
grafici di
Marco
Dalmasso
n.
5, marzo 1997
Militanti
e dirigenti del PCI negli anni '50 e '60 (Pietro Panero, Mila
Montalenti,
Mario
Romano, Walter Botto, Leopoldo Attilio Martino).
Introduzione
di Sergio Dalmasso
n.
6, maggio 1997
Lettere
dal confino di Giovanni Barale (1939-1941). A cura di Luigi Dalmasso
n.
7, ottobre 1997
Per
ricordare Michele Risso, Atti del convegno, Boves, 1 marzo 1996
(Luigi
Pellegrino, Sergio Dalmasso, Agostino Pirella, Franca Ongaro
Basaglia,
Pietro
Ingrao, Gianna Tangolo, Regina Chiecchio)
n.
8, gennaio 1998
Luigi
Borgna
Pietro
Panero
Appunti
sul PSI-PSDI (Mario Pecollo)
Lo
sciopero dei Pumet: Dronero, primavera 1954 (Carlo Giordano)
n.
9, maggio 1998
Il
PCI dalla "legge truffa" alla morte del "migliore"
(Sergio Dalmasso)
n.
10, luglio 1998
Comunisti
nel cuneese, scritti a cura di Giuseppe Biancani (1920-1981), a cura
di
Luigi
Bertone
n.
11, ottobre 1998
Fascismo
oggi, vecchi e nuovi miti (Marco Revelli)
"Incompiuti"
n.
12, marzo 1999
I
95 anni di Lucia Canova
Oronzo
Tangolo scritti
Testimonianze
di Mario Di Meglio e Sergio Dalmasso
n.
13, aprile 1999
Quell'estate
a Ulan Bator (Enzo Santarelli)
Maria
Capello, elogio dell'eresia (Sergio Dalmasso)
Oronzo
Tangolo (Roberto Baravalle)
Testimonianze
sul PSIUP cuneese (Mario Pellegrino, Eraldo Zonta,
Giuseppe
Costamagna)
"Incompiuti"
n.
14, maggio 1999
I
colloqui di Dresda
La
CGIL a Cuneo negli anni '50-'60 (Livio Berardo). Testimonianze di
Francesco
Angeloni, Giuseppe Trosso, Marcello Faloppa
"Incompiuti"
n.
15, agosto 1999
1945-1958.
Il caso Giolitti e la sinistra cuneese del dopoguerra (Sergio
Dalmasso)
n.
16, settembre 2000
1958-1976.
I rossi nella "granda". La sinistra in provincia di Cuneo
(Sergio Dalmasso)
n.
17, ottobre 2000
1976-1992.
Appunti sui partiti politici nel cuneese (Sergio Dalmasso)
n.
18, novembre 2000
Comunisti
a Mondovì: Mario Giaccone, Concetta Giugia.
Il
secondo "biennio rosso" (Sergio Dalmasso)
Il
sessantotto a Cuneo (Sergio Dalmasso)
n.
19, aprile 2002
Il
Novecento nella storiografia di fine secolo (Sergio Dalmasso,
Luigi
Bertone, Michele Girardo)
Dino
Giacosa: la coerenza (Sergio Dalmasso)
Riformismo
e riforme nella sinistra italiana (Sergio Dalmasso)
I
partiti socialisti, il centro- sinistra, la pianificazione nella
lettura
della rivista "Questitalia" (Sergio Dalmasso)
n.
20, aprile 2002
Dalla
Bolognina a Pristina: Cronologia di articoli su una resa:
29
ottobre 1998 - 29 maggio 2000 (Beppe Nicola)
Ricordi
di Maria Teresa Rossi e di Franco Camicia (Sergio Dalmasso)
n.
21, maggio 2002
1958-
1976. I rossi nella "Granda". La sinistra in provincia di
Cuneo
(Sergio
Dalmasso): Seconda edizione con breve appendice.
n.
22, agosto 2002
La
carovana di Lotta Continua e l'"eterno" problema
dell'organizzazione
(Diego
Giachetti)
Le
sofferenze del PCI torinese negli anni dei governi di unità
nazionale
(Ida
Frangella e Diego Giachetti)
n.
23, novembre 2002
Le
vicende elettorali delle forze politiche cuneesi (1945/2001)
Tabelle,
grafici, saggi introduttivi di Felice Paolo Maero e Sergio Dalmasso
n.
24, gennaio 2003
Convegno
Antisemitismo, razzismo, nuove destre (Luca Sossella, Luigi
Urettini,
Sergio
Dalmasso, Saverio Ferrari)
Un
altro comunismo? (Sergio Dalmasso)
Unificazione
europea? (Francesco Lamensa)
n.
25, febbraio 2003
Comunisti
a Mondovì. In ricordo di Concetta Giugia Giaccone.
Lelio
Basso nella storia del socialismo italiano (Luciano Della Mea, Rocco
Cerrato, Sergio
Dalmasso,
Piero Basso)
Rifondare
è difficile. Rifondazione Comunista dallo scioglimento del PCI al
“movimento dei
movimenti”
di Sergio Dalmasso: recensioni, schede, segnalazioni.
n.
26, giugno 2003
La
nuova sinistra italiana e la guerra di guerriglia durante gli anni
’60 (Aldina Trombini)
n.
27, gennaio 2004
Comunisti/e
a Boves (Bartolomeo Giuliano, Edda Arniani, Carmelo Manduca,
Giovanni “Spartaco”
Ghinamo)
a cura di Sergio Dalmasso.
n.
28, febbraio 2004
Alberto
Manna, Consigliere provinciale. Interventi al Consiglio provinciale
di Cuneo (1995-1999)
n.
29, giugno 2005
Come
era bella la mia Quarta (Silvio Paolicchi)
Ancora
su foibe, fascismo antifascismo (Gianni Alasia)
Piccole
storie dentro una grande storia (Enrico Rossi)
I
miei amici cantautori (Sergio Dalmasso)
n.
30, ottobre 2005
Rifondare
è difficile. Rifondazione Comunista dallo scioglimento del PCI al
“movimento dei
movimenti”
(Sergio Dalmasso)
n.
31 novembre 2005
Ristampa
quaderno n. 7 Per ricordare Michele Risso, Atti del convegno, Boves,
1 marzo 1996 (Luigi Pellegrino, Sergio Dalmasso, Agostino Pirella,
Franca Ongaro Basaglia, Pietro Ingrao, Gianna Tangolo, Regina
Chiecchio)
n.
32 marzo 2006
Appunti
sul Socialismo Italiano. a cura di Sergio Dalmasso
n.
33 settembre 2006
Comunisti/e
a Boves. a cura di Sergio Dalmasso
n.
34 gennaio 2007
La
Lega Nord nel Cuneese. a cura di Sergio Dalmasso e Fabio Dalmasso
n.
35 febbraio 2007
Gianni
Alasia
a cura di
Sergio Dalmasso, Vittorio Rieser, Fabio Dalmasso, Claudio Vaccaneo
n.
36 maggio 2007
Michele
Risso: scritti e bibliografia.. a cura di Sergio Dalmasso.
CIPEC
ATTIVITA’
Anno 1986-1987
Ciclo: "Marxismo
oggi":
- Marx oggi (Gian Mario
Bravo)
- Il marxismo nella
Terza Internazionale (Aldo Agosti)
- Per una ricostruzione
del pensiero marxista (Costanzo Preve)
- Il proletariato in
Marx (Cesare Pianciola)
- Il pensiero di Bloch
(Laura Boela)
Anno 1988-1989
Ciclo: "Le
rivoluzioni del '900":
- Rivoluzione francese
(Costanzo Preve)
- Rivoluzione sovietica
(Massimo Bontempelli)
- Rosa Luxemburg (Cosimo
Scarinzi)
- Stalin, Trotskij,
Bucharin, Togliatti (Antonio Moscato, Marco Rizzo)
- Rivoluzione cinese
(Edoarda Masi)
- Rivoluzione cubana
(Enrico Luzzati)
- La Palestina (Guido
Valabrega)
Anno 1989-1990
continuazione del Ciclo:
- I paesi dell'est
(Guido Valabrega)
- Il Sudafrica (Edgardo
Pellegrini)
Anno 1990-1991
Ciclo: "Marxismo
e...":
- Marxismo e femminismo
(Nadia Casadei)
- Marxismo e libertà
(Ludovico Geymonat)
- Marxismo e ecologia
(Tiziano Bagarolo)
- Marxismo e economia
(Riccardo Bellofiore)
- Marxismo e religione
(Emanuele Paschetto)
- Marxismo e psiconalisi
(Mario Spinella)
- Marxismo e nonviolenza
(Enrico Peyretti)
Anno 1991-1992
Ciclo: "500 anni
bastano":
- La storia della
conquista (Franco Surdich)
- Il popolo Mapuche -
Cile (Nelly Ayenao)
- Gli indiani del nord
(Nayla Clerici)
- La Chiesa in America
Latina (Giulio Girardi)
Anno 1992-1993
continuazione del Ciclo:
- Nord/Sud del mondo e
il debito (Gerson Guymaraes)
- L'ambiente e la
conferenza di Rio (Carlo Daghino)
- Proiezione video sugli
incidenti razziali a Los Angeles
- Che Guevara (Gianluca
Giachery e Sergio Dalmasso)
- Marxismo e nazionalità
(Renato Monteleone)
- Ricordo di Ludovico
Geymonat, filosofo della libertà (Fabio Minazzi)
Anno 1993-1994
Ciclo: "Marx oggi":
- Il marxismo in Italia (Costanzo Preve)
- Il marxismo nel terzo
mondo (Enrica Collotti Pischel)
- Marxismo oggi (Romano
Madera)
Ciclo: "Storia
della psicoanalisi"
- Freud (Alberto
Camisassa)
- Jung (Giorgio
Raimondi)
- Adler (Adriana Roatti
Garzillo)
- Reich (Beppe Corona e
Giorgina Lerda)
- Teorie freudiane e
pratica terapeutica (Angelo Mondini)
- La micropsicoanalisi
(Liliana Zonta)
Anno 1994-1995
Ciclo: "Analisi e
terapie":
- Gestalt (Mario Frusi)
- Comportamentismo (Aldo
Lamberto)
- Analisi sistematica
(Massimo Schinco)
- Terapia del contatto
(Luciano Jolly)
- Terapia del movimento
(Elide Bono)
- Psicodramma (Giorgio
Raimondi)
Fuori ciclo:
- La nuova sinistra: per
un bilancio storico politico (Marco Revelli, Paolo Ferrero, Oscar
Mazzoleni, Sergio Dalmasso)
Anno 1995-1996
Leone Trotsjij, un
fantasma nella storia (Gigi Viglino)
- Storia, geografa,
economia davanti ai problemi globali del mondo (Manlio Dinucci)
- Psichiatria
democratica (Agostino Pirella, Paolo Henry)
- Per ricordare Michele
Risso (Agostino Pirella)
Anno 1996-1997
- Guevara e l'America
latina (Antonio Moscato) - Il caso Sofri-Calabresi, Lotta Continua
(Ennio Pattoglio, Sergio Dalmasso)
- Democrazia Proletaria,
"Camminare eretti" (Giannino Marzola)
- Lelio Basso nel
socialismo italiano (Sergio Dalmasso)
- Storia critica della
repubblica (Enzo Santarelli)
- Riviste a sinistra
(Marco Scavino)
- Salute mentale e
superamento dei manicomi (Agostino Pirella)
Anno 1997-1998
Il Che, 30 anni dopo
(Antonio Moscato)
La rivoluzione Sovietica
(Roberto Preve)
La globalizzazione
(Franco Turigliatto, Raffaello Renzacci)
Una scelta di vita
(Eugenio Melandri)
Il Perù e l'America
latina (Isaac Velasco)
Il lavoro minorile
(Carlo Daghino
Il caso Sofri (Fabio
Levi)
Il Chiapas oggi (Luigi
Urettini, Chiara Vergano)
Ciclo: "Immagini
dell'uomo":
- Rapporto
terapeuta/paziente
- Rapporto
genitori/figli
- Rapporto uomo/donna
Anno 1998-1999
Kurdistan (Laura
Schrader, Hasti Fatah)
La rivoluzione non
violenta dei Sem Terra (Nadia Demond, Michelangelo Ramero)
Ciclo: "Quanto
vuoi?":
- Prostituzione e
immigrazione (Fredo Olivero)
- Aspetti antropologici
della prostituzione (Giancarlo Ferrero)
- Prostituta e cliente
(Franco Barbero, Carla Corso)
Ocalan libero (Laura
Schrader, Hasti Fatah)
Guerra e democrazia
(Raniero La Valle)
Nodi storici e religiosi
nei Balcani (mons. Diego Bona, Luigi Cortesi)
"Attraverso il
filo", il caso Silvia Baraldini (Maurizio Buzzini)
Anno 1999-2000
Ciclo: "100 anni di
psicoanalisi":
- Analista - cliente
- Le età
- Psicoanalisi e
sessualità
- Marxismo ed ecologia,
Ecofemminismo (Tiziano Bagarolo, Antonella Visintin)
- La globalizzazione in
America latina (Marina Ponti)
- Il viaggio del Che in
America latina (Antonio Moscato)
- Presentazione del
libro: Siamo solo noi, Vasco Rossi (Diego Giachetti)
- Quale carcere? (Beppe
Manfredi, don Elvio Davoli)
- Presentazione "Rivista
del Manifesto" (Giancarlo Aresta)
- Presentazione rivista
"Carta" (Marco Revelli)
Convegno “1968-1969,
il biennio rosso” (Luigi Urettini, Sergio Dalmasso, Diego
Giachetti, Carla Pagliero, Franco Bagnis, Fabio Panero, Vittorio
Bellavite, Carlo Carlevaris, Mario Cordero, Roberto Niccolai, Marco
Scavino, Vittorio Rieser, Carlo Marletti)
Ciclo Datemi una barca
(Scuola di pace di Boves):
- Giubileo e debito
internazionale (Giulio Girardi)
- Il sistema globale
(Manlio Dinucci)
- Teologia della
liberazione e diritti umani (Josè Ramos Regidor)
- I movimenti
rivoluzionari in America latina (Antonio Moscato)
Anno 2000-2001
- Sinistra alternativa,
plurale, sociale? (Marco Prina, Gianna Tangolo, Alfredo Salsano,
Fulvio Perini)
- I rossi nella Granda
(Mario Borgna, Alberto Cipellini, Sergio Dalmasso)
- Convegno: "Gli
anni '70" (Marco Scavino, Sergio Dalmasso, Vittorio Bellavite,
Diego Giachetti,
Diego Novelli, Mario
Renosio, Carla Pagliero, Gigi Malaroda, Pina Sardella, Nicoletta
Giorda)
- Convegno: "Razzismo,
antisemitismo, nuova destra" (Luigi Urettini, Moni Ovadia,
Saverio Ferrari, Guido Caldiron, Remo Schellino, Mario Renosio,
Sergio Dalmasso)
Ciclo Gli esclusi
(Scuola di pace di Boves)
- La conquista
dell'America dalla parte dei vinti (Giulio Girardi)
- Fabrizio De Andrè,
cantante degli umili (Romano Giuffrida)
- I nostri amici
cantautori (concerto)
Anno 2001-2002
- Presentazione del
libro “Rifondare è difficile” di Sergio Dalmasso (Gastone
Cottino)
- Convegno "Cosa
resterà di questi anni '80?" (Diego Berra, Sergio Dalmasso,
Claudio Mondino, Marinella Morini, Fulvio Perini, Lucio Magri, Marco
Revelli, Lidia Cirillo, Diego Giachetti, Carla Pagliero).
- La crisi argentina
(Antonio Moscato)
Ciclo "Gli esclusi"
(Scuola di pace di Boves)
- La canzone popolare
(Fausto Amodei)
- Un altro comunismo:
Leone Trotskij, Rosa Luxemburg (Antonio Moscato)
- La Palestina
(esponente dell'OLP)
Anno 2002-2003
- Globalizzazione ed
economia (Nerio Nesi)
- Sindacato e movimenti
dopo Firenze (Mario Agostinelli)
Convegno "Vent'anni
della Scuola di pace di Boves"
- La marcia delle donne
(Nicoletta Pirotta)
- L'alternativa al
liberismo e al terrorismo (Giulio Girardi)
- Vent'anni di storia,
vent'anni di guerre (Luigi Cortesi)
- Ernesto Balducci,
Gunther Anders e il pacifismo di oggi (Enzo Mazzi, Luigi Cortesi)
- Convegno "1945/1948:
gli anni della ricostruzione" (Sergio Dalmasso, Marinella
Morini, Martino Pellegrino, Laurana Lajolo, Elena Cometti, Fabio
Panero, Claudio Biancani, Michele Calandri, Paolo Perlo, Carla
Pagliero, Sofia Giardino)
Anno 2004-2005
- Ciao Raffaello, in
ricordo di Raffaello Renzacci (Giorgio Cremaschi, Fulvio Perini,
Franco Turigliatto, Rocco Papandrea, Sergio Dalmasso).
- Liberalismo e
liberismo (Sergio Dalmasso).
- Comunismo, marxismi,
democrazia (Sergio Dalmasso).
- Riccardo Lombardi, per
una società diversamente ricca (Nerio Nesi, Giancarlo Boselli,
Sergio Dalmasso).
- Rosa Luxemburg
(Sergio Dalmasso).
- Convegno “Gli anni
’60” (Daniela Bernagozzi, Carla Pagliero, Diego Giachetti,
Marinella Morini, Sofia Giardino, Chiara Rota, Giuliano
Martignetti).
Anno 2005-2006
- La stagione dei movimenti (Sergio
Dalmasso).
- La questione palestinese (Cinzia
Nachira)
- Film: Noi non abbiamo vinto?
(Gianni Sartorio, Giampiero Leo, Sergio Dalmasso)
Anno 2006-2007
- 1956: l’invasione dell’Ungheria
(Mario Martini, Gianni Alasia, Sergio Dalmasso)
- Comunisti/e a Boves (Nello Pacifico,
Sergio Dalmasso)
Anno
2006-2007
-
“40 anni senza il Che” (Antonio Moscato, Giacomo Divizia, Sergio
Dalmasso)
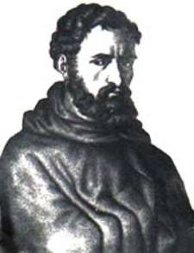 nno
1300: anno del Giubileo e del perdono universale. Perdono per tutti i
malfattori, ma non per Gherardino Segalello, che viene posto al rogo
a Parma. La sua colpa? Aver dato vita al movimento dei "Fratelli
Apostolici". Nel 1260 circa, l'umile Gherardino aveva chiesto di
essere ammesso nel convento dei frati minori (francescani) di Parma.
Permesso rifiutato. Allora vende la sua piccola casa ed il suo
piccolo orto, getta i soldi così ricavati ai poveri (proprio come
aveva fatto San Francesco), ed inizia una vita nuova basata su pochi,
essenziali concetti: l'imitazione di Cristo ("seguire nudi il
Cristo nudo"), il rifiuto di ogni possesso e accumulazione
(quindi la povertà assoluta) e dunque le elemosine in una esistenza
itinerante, nella convinzione che solo una tale realtà esistenziale
potesse interpretare nel giusto modo il messaggio del Vangelo. E' il
rifiuto, messo in pratica, della via adottata dalla chiesa di Roma
(possesso, ricchezza, potere).
nno
1300: anno del Giubileo e del perdono universale. Perdono per tutti i
malfattori, ma non per Gherardino Segalello, che viene posto al rogo
a Parma. La sua colpa? Aver dato vita al movimento dei "Fratelli
Apostolici". Nel 1260 circa, l'umile Gherardino aveva chiesto di
essere ammesso nel convento dei frati minori (francescani) di Parma.
Permesso rifiutato. Allora vende la sua piccola casa ed il suo
piccolo orto, getta i soldi così ricavati ai poveri (proprio come
aveva fatto San Francesco), ed inizia una vita nuova basata su pochi,
essenziali concetti: l'imitazione di Cristo ("seguire nudi il
Cristo nudo"), il rifiuto di ogni possesso e accumulazione
(quindi la povertà assoluta) e dunque le elemosine in una esistenza
itinerante, nella convinzione che solo una tale realtà esistenziale
potesse interpretare nel giusto modo il messaggio del Vangelo. E' il
rifiuto, messo in pratica, della via adottata dalla chiesa di Roma
(possesso, ricchezza, potere).
 ominciano
ad affluire seguaci di Gherardino (il quale tuttavia rifiuterà
sempre di essere considerato "capo", in omaggio ad una
concezione integralmente comunitaria ed antigerarchica), e via via il
consenso popolare cresce, tanto che le file degli Apostolici si
ingrossano e moltissimi, uomini e donne, aderiscono a questo
movimento. Gherardino, nella sua semplicità, è un grande
comunicatore: coloro che aderiscono al movimento vengono privati dei
vestiti e indossano una tunica bianca (l'unica cosa che possiedono),
rifiutano persino, dell'elemosina, il pane superfluo che non può
essere consumato immediatamente, egli stesso si presenta sulla
pubblica piazza attaccato al seno di una donna come fosse un neonato
lattante (a simboleggiare la rinascita dello spirito cristiano in una
nuova éra di purezza totale), fa predicare in chiesa persino i
bambini. Insomma, il contenuto del messaggio degli Apostolici (che si
chiamano anche "minimi" per segnare la differenza con i
"minori"- francescani i quali si erano integrati, in fondo
tradendo l'insegnamento del loro fondatore Francesco d'Assisi, nei
meccanismi potere-ricchezza della chiesa di Roma), e le forme della
predicazione ottengono via via un enorme successo e adesione
popolare, al punto che la gente abbandona i riti cattolici per
affluire in massa alle "prediche" degli Apostolici.
Gherardino invia anche diversi Apostolici a portare il proprio
messaggio in terre lontane. Questo enorme successo (riconosciuto
dalle più autorevoli fonti storiografiche cattoliche dell'epoca) non
può più essere tollerato dalla chiesa romana: il mite Gherardino
(pacifista integrale) viene imprigionato, alcuni apostolici vengono
messi al rogo, e infine, nel 1300, Gherardino stesso viene arso vivo
sulla pubblica piazza, nel nome del Signore. Ma il rogo di Gherardino
Segalello, anziché spegnere il movimento apostolico, per uno di
quegli strani "scherzi" della storia, segna invece l'inizio
di una vicenda del tutto originale, e di enorme portata, nel medioevo
italiano. Tra i molti che erano venuti in Emilia anche da lontano per
partecipare al movimento apostolico, vi è Dolcino, nativo di Prato
Sesia (Novara). Dopo la morte del fondatore, Dolcino di fatto assume
il ruolo di leader del movimento, il cui nucleo "dirigente",
sotto la pressione dell'Inquisizione, si sposta nel 1300 dall'Emilia
al Trentino (vengono chiamati qui ed accolti da loro amici e
compagni). La repressione tuttavia li segue anche lì, ove tre
apostolici (due uomini e una donna) vengono posti al rogo. Nel
1303/1304 ecco allora Dolcino, con il gruppo degli Apostolici più
fedeli (uomini, donne, vecchi e bambini), partire nel lungo viaggio
che li porterà, attraverso le montagne lombarde (presso Chiavenna vi
è tuttora un paese che si chiama Campodolcino) in Valsesia. La
Valsesia è la terra d'origine di Dolcino, qui egli conta amici, ed è
naturale che, per salvarsi, egli pensi a questa meta. Tra le donne
che fanno parte di questo gruppo vi è la bellissima Margherita di
Trento, di nobili origini, compagna di Dolcino.
ominciano
ad affluire seguaci di Gherardino (il quale tuttavia rifiuterà
sempre di essere considerato "capo", in omaggio ad una
concezione integralmente comunitaria ed antigerarchica), e via via il
consenso popolare cresce, tanto che le file degli Apostolici si
ingrossano e moltissimi, uomini e donne, aderiscono a questo
movimento. Gherardino, nella sua semplicità, è un grande
comunicatore: coloro che aderiscono al movimento vengono privati dei
vestiti e indossano una tunica bianca (l'unica cosa che possiedono),
rifiutano persino, dell'elemosina, il pane superfluo che non può
essere consumato immediatamente, egli stesso si presenta sulla
pubblica piazza attaccato al seno di una donna come fosse un neonato
lattante (a simboleggiare la rinascita dello spirito cristiano in una
nuova éra di purezza totale), fa predicare in chiesa persino i
bambini. Insomma, il contenuto del messaggio degli Apostolici (che si
chiamano anche "minimi" per segnare la differenza con i
"minori"- francescani i quali si erano integrati, in fondo
tradendo l'insegnamento del loro fondatore Francesco d'Assisi, nei
meccanismi potere-ricchezza della chiesa di Roma), e le forme della
predicazione ottengono via via un enorme successo e adesione
popolare, al punto che la gente abbandona i riti cattolici per
affluire in massa alle "prediche" degli Apostolici.
Gherardino invia anche diversi Apostolici a portare il proprio
messaggio in terre lontane. Questo enorme successo (riconosciuto
dalle più autorevoli fonti storiografiche cattoliche dell'epoca) non
può più essere tollerato dalla chiesa romana: il mite Gherardino
(pacifista integrale) viene imprigionato, alcuni apostolici vengono
messi al rogo, e infine, nel 1300, Gherardino stesso viene arso vivo
sulla pubblica piazza, nel nome del Signore. Ma il rogo di Gherardino
Segalello, anziché spegnere il movimento apostolico, per uno di
quegli strani "scherzi" della storia, segna invece l'inizio
di una vicenda del tutto originale, e di enorme portata, nel medioevo
italiano. Tra i molti che erano venuti in Emilia anche da lontano per
partecipare al movimento apostolico, vi è Dolcino, nativo di Prato
Sesia (Novara). Dopo la morte del fondatore, Dolcino di fatto assume
il ruolo di leader del movimento, il cui nucleo "dirigente",
sotto la pressione dell'Inquisizione, si sposta nel 1300 dall'Emilia
al Trentino (vengono chiamati qui ed accolti da loro amici e
compagni). La repressione tuttavia li segue anche lì, ove tre
apostolici (due uomini e una donna) vengono posti al rogo. Nel
1303/1304 ecco allora Dolcino, con il gruppo degli Apostolici più
fedeli (uomini, donne, vecchi e bambini), partire nel lungo viaggio
che li porterà, attraverso le montagne lombarde (presso Chiavenna vi
è tuttora un paese che si chiama Campodolcino) in Valsesia. La
Valsesia è la terra d'origine di Dolcino, qui egli conta amici, ed è
naturale che, per salvarsi, egli pensi a questa meta. Tra le donne
che fanno parte di questo gruppo vi è la bellissima Margherita di
Trento, di nobili origini, compagna di Dolcino.
 er
"bioregione" si intende un luogo geografico riconoscibile
per le sue caratteristiche di suolo, di specie animali e vegetali, di
microclima, oltre che per la cultura umana che da tempo immemorabile
si è sviluppata in armonia con tutto ciò. Le Valli alpine, come la
Valle Sesia, costituiscono - o meglio, costituivano - bioregioni, e
cioè insieme biologici tendenti all'autosufficienza ed
all'autoproduttività, che si sono adattati alle condizioni dei loro
habitat dove si realizza un "equilibrio circolare" tra
tutti i fattori (produttori di energia, consumatori di energia,
eliminatori dei rifiuti). Le popolazioni inserite nella bioregione
formano comunità locali conferenti veste concreta a quello spirito
di Gemeinchaft,
cioè di "comunità di destino" entro cui si esprimono
secoli di produzione culturale,
er
"bioregione" si intende un luogo geografico riconoscibile
per le sue caratteristiche di suolo, di specie animali e vegetali, di
microclima, oltre che per la cultura umana che da tempo immemorabile
si è sviluppata in armonia con tutto ciò. Le Valli alpine, come la
Valle Sesia, costituiscono - o meglio, costituivano - bioregioni, e
cioè insieme biologici tendenti all'autosufficienza ed
all'autoproduttività, che si sono adattati alle condizioni dei loro
habitat dove si realizza un "equilibrio circolare" tra
tutti i fattori (produttori di energia, consumatori di energia,
eliminatori dei rifiuti). Le popolazioni inserite nella bioregione
formano comunità locali conferenti veste concreta a quello spirito
di Gemeinchaft,
cioè di "comunità di destino" entro cui si esprimono
secoli di produzione culturale,